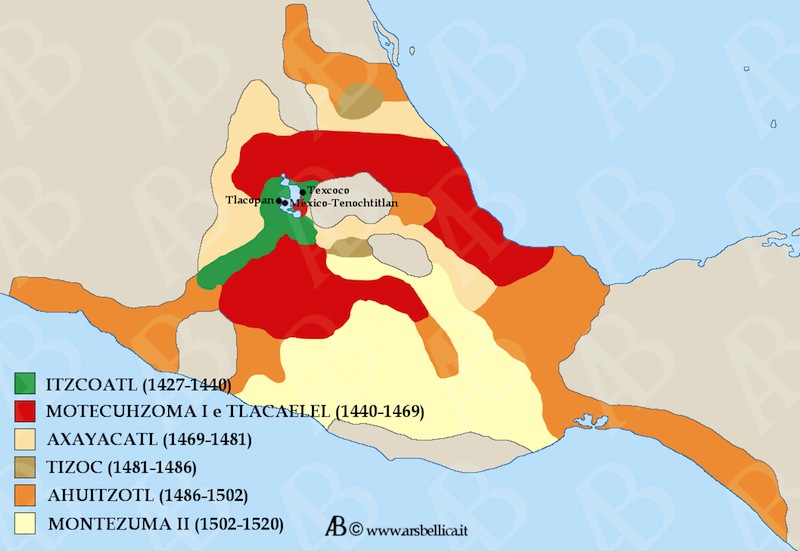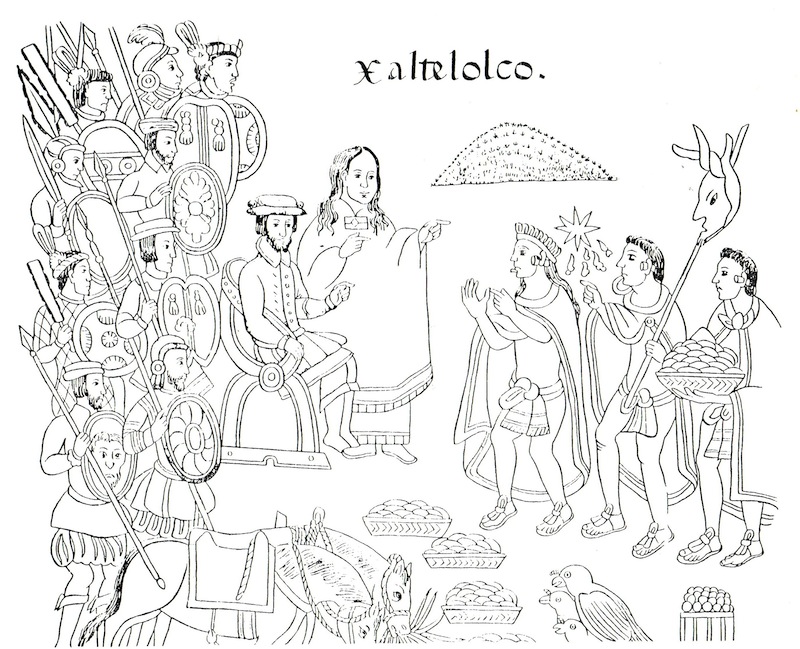L’ILLUMINISMO.
L'Illuminismo è un movimento non solo filosofico ma più generalmente culturale (letterario, artistico, sociale, politico, scientifico) che si sviluppa in Europa nel diciottesimo secolo.
Sua caratteristica principale è la fiducia e la celebrazione della ragione umana, più in particolare, metaforicamente, dei "lumi" della ragione, perché capaci di guidare e di "illuminare" tutti gli aspetti della conoscenza e del comportamento umano. Da qui, appunto, il termine di "Illuminismo".
Il movimento illuminista si diffonde nei più avanzati paesi europei: Gran Bretagna, Francia, alcuni Stati italiani e tedeschi. Ha i suoi primi inizi in Inghilterra, dove ormai la borghesia aveva definitivamente superato l'aristocrazia agraria nella produzione della ricchezza, affermandosi come classe sociale preminente nell'economia. Ma è in Francia, soprattutto con Charles Montesquieu (1689-1755) e con François Voltaire (1694-1778), che l’Illuminismo ha il massimo sviluppo, dove forte era il contrasto tra la borghesia, che stava diventando sempre più importante, ed il sussistente sistema politico, ancora di carattere aristocratico e feudale. Tant'è che verso la fine del Settecento gli interessi della borghesia e le idee di libertà e di uguaglianza civile condussero allo scoppio della Rivoluzione francese, che comportò la fine del vecchio regime monarchico, assoluto e aristocratico, ma altresì, nel momento più cruento della rivoluzione, la decapitazione di molti degli stessi massimi rappresentati dell’Illuminismo. La ghigliottina non risparmiò neppure le prime coraggiose femministe, teoriche dei diritti della donna. Una rivoluzione nata nel segno dei diritti dell’uomo ma terminata con la dittatura di Napoleone, con la restaurazione dell’antico regime e, contro il cosmopolitismo illuminista, con la rinascita degli egoismi nazionali.
In Italia e in Germania l'Illuminismo non fu tanto il frutto della classe borghese, meno progredita rispetto all'Inghilterra e alla Francia, quanto di taluni prìncipi "illuminati", di taluni sovrani di idee avanzate che vollero governare secondo una mentalità moderna e progressista.
In generale si può dire che l'Illuminismo è stato l'ideologia della borghesia in ascesa, destinata a diventare classe sociale prevalente. Sue caratteristiche principali sono:
1. la fiducia nella ragione umana, nella riflessione razionale, controllata e verificata sulla base dell'esperienza, cui è affidato il progresso umano;
2. la liberazione dell'uomo, mediante la diffusione del sapere, dall’ignoranza, dall’oppressione e dalle concezioni assurde della tradizione;
3. l'avvento di una nuova concezione di società tollerante, in cui garantire i diritti naturali e la convivenza sociale abbattendo i privilegi sociali di origine feudale;
4. lo sviluppo di una nuova religione, non rivelata e trascendente, ma basata su principi razionali naturali, vale a dire quelli del deismo (la Dea ragione) e del giusnaturalismo (il diritto naturale).
La cultura illuminista è laica, terrena, pubblica, progressista e critica.
È laica perché crede nella separazione tra Chiesa e Stato; è tollerante in materia di liberta di pensiero e religiosa, ma condanna ogni fanatismo e superstizione.
È terrena perché l'uomo più non si sente, secondo una certa teologia medievale, un pellegrino esiliato sulla terra, considerata una "valle di lacrime", un luogo di passaggio in attesa della vita ultraterrena. Anzi, è orgoglioso della sua condizione di essere terreno, unico luogo in cui gli è concesso di vivere. Pur consapevole dei limiti delle capacità umane, l'illuminista si impegna per il benessere e la felicità sua e della società. Il male non è più concepito come conseguenza del peccato originale e come debolezza e colpa individuale ma soprattutto come conseguenza dell'ignoranza, per cui diventa importante l'istruzione e l'educazione.
È pubblica perché il sapere e la conoscenza non devono essere il privilegio solo di pochi fortunati ma essere diffusi ed estesi al più ampio numero possibile di persone.
Sorgono nuovi luoghi e occasioni di cultura, quali le Accademie, la Massoneria (ispirata ad ideali di pace e tolleranza di carattere filantropico, che sviluppa altresì motivi anticlericali e antidogmatici), i salotti letterari, nuove forme letterarie quali l'epistolario e i saggi, spesso nella forma del pamphlet.
Ai fini della diffusione del sapere è stato particolarmente rilevante il progetto dell’"Enciclopedia" perseguito dagli illuministi francesi Diderot e D’Alembert, vale a dire la creazione di un'opera che, come le enciclopedie contemporanee, contenga e descriva, in maniera comprensibile per il pubblico mediamente istruito, i concetti, le teorie, le conoscenze raggiunte dalle varie scienze, perché tutti possano apprendere ed aumentare la loro conoscenza.
È progressista perché gli illuministi hanno fiducia nella circolazione del sapere per far progredire la libertà e la società. Quella di progresso è un'idea fondamentale dell'Illuminismo. Per gli illuministi la storia e la conoscenza umana, come pure le condizioni sociali ed economiche dei popoli, anche se potranno avere momenti di arresto o di regresso, sono tuttavia tendenzialmente destinate a progredire e migliorare sempre di più.
È critica perché la cultura illuminista non dà niente per scontato: nessuna spiegazione deve essere accettata solo perché fornita da pensatori antichi ritenuti autorevoli e indiscutibili. Anche l'Illuminismo combatte il "principio di autorità". Ogni spiegazione può essere accettata solo dopo essere stata analizzata e "criticata" dalla ragione nonché, ogni qualvolta possibile, verificata in base all'esperienza.
Nel complesso, dunque, la cultura e la filosofia dell'Illuminismo sono di stampo ottimistico.
Nel corso dell'Illuminismo si afferma un nuovo tipo di intellettuale, che non è più il pensatore solitario e astratto del passato, ma è persona impegnata sia a cambiare in meglio la società sia a diffondere il sapere, facendo uso di un linguaggio divulgativo affinché anche i non specialisti possano aumentare il loro sapere.
L'uso della ragione, oltre che critico, deve essere assolutamente libero:
viene difesa la libertà di parola, di scrivere e di pensare, senza vincoli e pregiudizi imposti da altri.
Scrive Kant, il maggiore dei filosofi illuministi, che l'Illuminismo è quel movimento culturale e di pensiero il quale crede che ciascun uomo possa conoscere e agire avendo fiducia nelle capacità del proprio intelletto. Pur rispettando le leggi dello Stato, deve essere possibile la pubblica e libera discussione delle idee e delle opinioni di ciascun cittadino; ciò permetterà di superare errori ed ostacoli e di migliorare la vita della collettività. Il motto di Kant è "sapere aude", "osa sapere", abbi il coraggio di servirti della tua propria intelligenza, senza subire per forza la guida di un altro, senza farti intimidire dall'autorità degli antichi maestri.
Se l’Illuminismo si presenta come movimento di evoluzione culturale, di emancipazione dell’uomo dal suo “stato di minorità”, di liberazione dalle astratte pretese metafisiche anche rispetto a ciò che non appare chiaro e distinto alla ragione, di affrancamento dalla superstizione, dal principio di autorità, dalla sudditanza feudale ed ecclesiastica, sorge peraltro l’esigenza di bilanciare i giudizi positivi con quelli negativi o contenenti riserve.
Vi è una vasta letteratura critica in merito, sia storica, ottocentesca, come quella di De Maistre, Taine, Tocqueville, sia contemporanea. Ciò che è importante rilevare fin da subito è che, se la critica ottocentesca nasce prevalentemente da un conservatorismo che vede nell’Illuminismo il turbamento di un ordine, la critica novecentesca mette in evidenza come esso, identificato quale ideologia della borghesia, sia alla base della degenerazione tecnologica venuta a prodursi nella società, dominata da un’arida ragione strumentale. Vale al riguardo, quale esempio tra i più significativi, l’opera, apparsa nel 1944, “Dialettica dell’Illuminismo” di Adorno e Horkheimer, esponenti della denominata “Scuola di Francoforte”.
In tale opera l’Illuminismo è traguardato come linea di pensiero e percorso della ragione che, partendo già da Senofane, e poi soprattutto da Cartesio e Bacone, ha preteso di razionalizzare il mondo al solo fine di renderlo manipolabile e sfruttabile, nell'obiettivo di togliere all'uomo la paura e di renderlo padrone. Ma questo tipo di illuminismo va incontro all'autodistruzione poiché paralizzato dalla paura della verità. In esso è prevalsa l'idea che il sapere è tecnica anziché critica. Quel che importa non è la verità delle teorie ma la loro funzionalità. La pretesa di accrescere sempre di più il potere sulla natura unita alla separazione dell'uomo dalla natura hanno determinato il prevalere dell'apparato tecnico e la perdita dell'autonomia del singolo individuo. L'uomo è diventato un ingranaggio del sistema di cui sfruttare le capacità senza nessuna gratificazione a livello personale. L'Illuminismo prometteva libertà e autonomia per l'uomo, liberato dai dogmi e credenze della metafisica e della religione, ma in realtà ha dato origine a ciò che inizialmente aveva negato, vale a dire a nuove religioni, ai nuovi miti del progresso tecnologico e dell'efficienza, senza porsi il problema della felicità umana. Da ciò l’esito di un ribaltamento dialettico dell'Illuminismo: la volontà di un crescente dominio sulla natura si è rovesciata in un progressivo dominio dell'uomo sull'uomo e in un generale asservimento dell'individuo all'apparato tecnico e al sistema sociale. Di fronte alle potenze economiche il singolo è ridotto a zero.
Francesco Lorenzoni, 17 gennaio 2018
L’ESPERIENZA.
(liberamente tratto e rielaborato da Vito Ceravolo: “Mondo. Strutture portanti e inferenze”)
In termini filosofici l’esperienza è definibile come l’insieme dei fatti e dei fenomeni, esterni e interni, acquisiti dal soggetto attraverso la sensazione ed elaborati attraverso la riflessione.
Salvo scambi esperienziali intersoggettivi, ha impronta soggettiva.
E’ esterna se concerne oggetti presenti in natura, denominata in tal fatta come sensazione; è interna se concerne oggetti mentali, ovvero stati d’animo e valori interiorizzati.
Vi è corrispondenza tra oggetti percepiti e soggetto percipiente:
1. ad un oggetto meccanico corrisponde un soggetto reagente;
2. ad un oggetto istintivo corrisponde un soggetto vivente;
3. ad un oggetto mentale corrisponde un soggetto pensante.
L’oggetto e il soggetto specifici sono relativi al ruolo che hanno nella narrazione perciò, secondo la proposizione formulata, ciò che prima è soggetto e l’altro oggetto può essere invertito. Nondimeno, se ogni oggetto può essere espresso come particolare soggetto e viceversa, rimane invece invariato il costrutto in ordine al quale qualsivoglia esperienza soggettiva non sarà mai separata dall’oggetto per cui si dà e non esisterà esperienza alcuna non riferibile ad un determinato soggetto esperente, fosse pure l’esperienza di sé, in virtù del fatto che ogni soggetto è un particolare oggetto: se l’oggetto non fosse, l’esperienza soggettiva oggettivamente non sarebbe. L’oggetto tende al generale, il soggetto al particolare, “ove ogni genere è di un particolare come ogni particolare è di un genere” (Hegel), così da non poter mai avere a che fare con soggetti e oggetti sciolti fra loro. Ogni esperienza soggettiva è piena dei valori oggettuali interiorizzati, dei valori dell’oggetto esperito o parte di essi.
Già questa considerazione è da sé bastevole a dar conto della natura estesamente composita del concetto di esperienza. Dall'inizio è stata pensata sulla linea della distinzione e dell'integrazione di percezioni e ricordi. A partire da Aristotele l'esperienza esige capacità di astrazione ed è in rapporto con la teoria. Si può volgere l'esperienza contro la teoria, ma allora divengono impossibili concetti sintetici. Questa convinzione ha condotto Kant a legare l'esperienza all'attività categoriale dell'intelletto, venendo così a sussumere anche il problema del rapporto di universale e particolare, di apriori e di sintetico, problema ripreso da Hegel nell’asserire che non si può togliere dalla parola l’universale, a cui aggiunge che non si può toglierle neanche il particolare.
Il pensiero non è separato dall'esperienza:
c'è un'esperienza del pensare e non solo un pensare l'esperienza.
La fenomenologia chiede inoltre come si abbia esperienza dell'esperienza.
Sono questi i problemi con cui deve cimentarsi il concetto di esperienza: esperienza come percezione e come processo di astrazione; concretezza e singolarità da una parte, universalità dall'altra. L'esperienza è polivalente; può essere determinata nel suo significato solo settorialmente. Perciò il tentativo di portare il termine “esperienza” ad un comune denominatore concettuale appare impresa quasi disperata. Si può tentare di configurare l'elemento comune dei plurimi concetti settoriali di esperienza soltanto tramite un’immagine o metafora che esprimano la maniera complessa in cui hanno origine le conoscenze umane e il sapere, laddove la complessità di quell'origine sta nel fatto che vi circolano tutte le dimensioni della conoscenza umana, visione, osservazione, contatto vissuto, intuizione, comprensione, tali che la concettualizzazione può distinguere ma non integralmente unificare.
Ciò che si percepisce (oggetti meccanici, istintivi o mentali) diventa valore interiorizzato, trasportato nella propria esperienza interna attraverso relazioni in grado di produrre una determinata e caratteristica configurazione. Sicché ogni esperienza è un tessuto relazionale costituito dalla reciproca influenza che si instaura tra oggetto esperito e soggetto esperente, la quale porta, nei soggetti e oggetti in relazione, ad una più modificazioni nello stato del corpo come pure delle strutture cerebrali che formano le mappe corporee che stanno alla base del pensare. Nel quadro delle relazioni soggetto-oggetto, il medesimo oggetto, da altre inquadrature, può essere esperito in misura diversa relativamente alle diversità dei soggetti: “lo stesso” è il medesimo preso per sé, ma diverso nel risultato del suo rapporto con altro, talché, per il principio di partecipazione, può essere predicato in molte maniere, separate sotto alcuni aspetti ma unite in quello “stesso”: “lo stesso” rimane identico in sé lasciando l’opportunità ai molti di predicarlo secondo la loro personale relazione. Ogni soggetto predica, ognuno a modo suo, l’interezza e unicità dello stesso oggetto, così da averlo immediatamente in forma personale e con l’aspirazione, insieme, a possederlo in modo sempre più obiettivo e universale (Platone, dal dialogo il “Parmenide”).
Nel soggetto umano ad influenzare la percezione non sono soltanto i valori attribuiti all’oggetto esperito ma pure, e non di meno, l’ambiente dell’esperire. In funzione dell’ambiente il medesimo valore può essere esperito in misura diversa relativamente al luogo in cui viene osservato o da cui viene osservato. E’ il “relativismo della percezione”, non l’inganno o l’illusione della natura ma il risultato di una o l’altra interazione fra stati di cose, loro apparati di percezione e luoghi di osservazione.
“Percepire qualcosa” significa “cogliere come appare” e l’apparire è sempre dato dall’interazione fra soggetto, valore dell’oggetto osservato e ambiente. L’esperienza ci insegna che l’apparire di uno stesso oggetto può accadere in modi tanto diversi quanto diversi sono i soggetti percipienti e gli ambienti spazio-temporali di partecipazione, cosicché vige una variabilità dell’apparire che offusca ogni stabilità dell’esperienza, ossia la ragione di tale apparire. In quanto apparente, l’apparire necessita di ciò da cui appare, ovvero dell’“in sé”, della ragione del proprio apparire. L’apparire non ha ragioni di per sé, che stanno invece nell’in sé da cui appare. L’“in sé” per cui accade l’apparire delle cose è la ragione dell’apparire la quale tuttavia, a sua volta, non appare, non è percepibile dai sensi ma è sovrasensibile. Eppure come “valore” deve essere di principio accessibile. Il fenomeno, di fatto apparendo, necessita di una realtà in sé da cui apparire, quindi di un valore da cui apparire che, in quanto tale, è di principio accessibile (Kant). Si ha accesso all’in sé tramite lo strumento astratto della razionalità. L’uomo possiede la razionalità e non la ragione delle cose, diversamente avremmo la verità di tutto. Mediante la razionalità, si può dire, le narrazioni del soggetto razionalizzante catturano in certo qual modo la realtà dell’oggetto narrato, come se la verità coincidesse con uno sguardo dal di fuori delle cose, benché non si possa contemplare qualcosa collocandosi all’esterno: si è sempre dentro a ciò che si contempla. Si dice che “mondo” e “uomo” non sono oggetti né soggetti di un sapere che li possa studiare “da fuori”. Talché la razionalità, l’abilità astratta di cogliere la ragione in sé delle cose, “è la pretesa di parlare dell’universo come se lo guardassimo attraverso la sua universalità, da dentro i suoi occhi, validi per ogni cosa” (Carlo Sini). Non si può certo uscire da se stessi, ma ciò non esclude che, esperendo le cose, si possa entrare in contatto con la cosa al di fuori di noi. “E porteremo dentro noi l’universo se da un frammento suo ingerito lo sapremmo riprodurre tutto. Ben aggrappandoci alla teoria della terra sotto i piedi, del tutto bisogna averne principio per cercare la corretta regolazione su ogni cosa” (D. Bohm: la struttura complessiva è identificabile in ogni sua singola parte).
Se la ragione delle cose è astratta, essa viene peraltro elaborata e intersoggettivamente comunicata dalla razionalità attraverso linguaggi, simboli, gesti, contestualizzazioni. Ragione e fenomeno non sono il medesimo valore; la prima è sovrasensibile e solo intellegibile; il secondo è sensibile e solo percepibile. Non vi è identità fra ragione e fenomeno ma solo adeguamento, sicché la verità diventa fede in ordine all’adeguamento dell’astratto col concreto. Non esiste uno specchio tramite cui guardare l’”in sé”: esso non ha immagine propria poiché ogni immagine è un apparire. Così, benché la ragione sia in sé la costante per ogni cosa, e la razionalità il mezzo con cui reificarla e comunicarla, l’adeguamento dell’astratto in sé al fenomeno concreto è un salto di fede mosso da idea di verità: ogni sapere, per principio, ha un punto ove si affida alla fede in ciò che non vede.
La ragione è uguale in sé in ogni situazione, anche davanti ai diversi linguaggi che la possono esprimere: l’interferenza dei linguaggi non altera le verità di ragione. Ponendo i diversi linguaggi sul medesimo ordine di discorso, la stessa ragione può essere parimenti raccontata da linguaggi diversi convenientemente tradotti. Ogni parola significa l’oggetto denotato, riferito sia al mentale che al fisico, ove è il mentale ad attribuire il significato ma è il fisico ad avercelo. Il significato inerisce immediatamente a come il soggetto percepisce l’oggetto, quindi in misura personale. Ma quando la parola acquista significato a partire da una intersoggettiva “modalità di frequentazione del mondo”, si può passare da un contesto personale ad un contesto universale. Allora anche la parola, come ogni altro essere, è portatore assieme di caratteri individuali e universali sotto rapporti diversi: la realtà del mondo è stabile nel suo universale, frequentando la ragione in sé, e mutevole nel personale, frequentando il fenomeno (C. Sini).
Ciò che immediatamente si percepisce della realtà è il suo divenire, il passaggio da uno stato all’altro, il che comporta che ogni nostro conoscere col determinare delimita, mentre il divenire che scorre, se determinato, si fermerebbe. Non si può in alcun caso conoscere il divenire ma solo gli stati del suo passaggio, e “stato” e “divenire” non sono la stessa cosa. Non c’è scienza di ciò che fluisce ma solo degli stati del suo fluire: il divenire, nel suo apparire fenomenico, si può avvertire ma non letteralmente conoscere. Tuttavia, se lo svolgersi fenomenico si può solo presentire, gli stati fenomenici hanno anch’essi la loro ragione, che l’intelligibile può quindi conoscere. Discende che le definizioni possano riferirsi tanto alle cose in sé quanto ai vari stati del sensibile. Si ricavano due ambiti di studio: lo studio astratto e metafisico della ragione con la ragione e lo studio concreto e ontologico delle cose, ancora con la ragione.
Eppure, gli spiriti più inqueti mal sopportano i vincoli ferrei dell’analisi, sospinti dalla seduzione di una rivoluzione liberatoria e immaginifica di prospettiva. “Cadono meteoriti sulla cattedrale filosofica, la fenice è sempre più bella. Si guarda allo specchio e, come sempre, troverete poco di meritevole nel dire qualcosa di semplice, di più nel rendere semplici cose mai dette. E toccherete con mano. In questo salto paradigmatico i discorsi si muovono così semplici e accessibili da imbarazzare ogni elitaria classe autoproclamatasi detentrice di una conoscenza oscura, laddove la semplicità è qui il segno di alta e angelica conoscenza, tagliata da poetica come segno di profonda e carnale visione. Qui il filosofo è il dono che rende accessibile ai molti la conoscenza anche delle cose oscure e più complesse. Ma non abbiamo illusioni di sorta, o di spegnere l’intero scibile con questa goccia gettata sul fuoco della conoscenza; solo l’ardire di minare la filosofia per dare spazio a un’evoluzione del pensiero, ad una nuova specie”
(Rudolf Steiner)
Francesco Lorenzoni
LA FENOMENOLOGIA
Molte correnti filosofiche contemporanee hanno preso posizioni polemiche nei confronti del Positivismo a motivo della concezione deterministica e dogmatica assunta in ordine alla scienza nonché per l’assoluta fiducia nei “fatti”, inconsapevole che essi non sono in sé immediatamente significanti se non attraverso l’interpretazione. Tra le correnti antipositivistiche si colloca anche la "Fenomenologia", fondata da Edmund Husserl. Altrettanto, la fenomenologia si oppone allo psicologismo, ovvero alla tesi che asserisce il derivare della logica e dei concetti logici dalla struttura psicologica dell'uomo. Si contrappone altresì all'idealismo e al neoidealismo, tuttavia non senza taluni scivolamenti in tal verso.
Letteralmente fenomenologia significa scienza dei fenomeni. I fenomeni di cui si occupa sono sia quelli fisici sia quelli psichici, mentali (le credenze, le persuasioni, le opinioni, i punti di vista, le emozioni, i sentimenti) secondo il modo in cui si danno, si mostrano, ai vissuti coscienziali. Mentre il senso comune, chiamato “atteggiamento naturale”, percepisce i fenomeni come oggetti esterni indipendenti, la fenomenologia viceversa, rifiutando questa prospettiva che, in fondo, è propria anche di tanta scienza, non ignora che essi sono un apparire colti in ogni caso attraverso il filtro della soggettività e non come oggetti in sé. In particolare, la fenomenologia studia i fenomeni non tanto nei loro aspetti particolari, esteriori, fisici e fisiologici, come fa la scienza, ma per coglierne anzitutto le essenze, il loro senso essenziale, il loro nativo darsi e presentarsi alla coscienza quale intuitivamente avvertito nel farne esperienza: il motto della fenomenologia invita espressamente a "tornare alle cose", cioè all’originario mostrarsi in cui le cose si rivelano nei modi, intuitivi e precategoriali, del loro coscienziale apparire.
Più che una teoria sulla realtà, la fenomenologia è anzitutto un metodo di indagine mediante cui descrivere i modi tipici, il tratto essenziale, con cui i fenomeni sono colti dalla coscienza depurati dagli aspetti particolari. Quindi è scienza delle essenze quali dalla coscienza desunte e non scienza dei dati fenomenici come inteso dalle scienze fisiche, fisiologiche e psicologico-meccanicistiche. Nelle particolarità del fenomeno esperito la coscienza è sempre volta a rintracciare la specie generale cui esso appartiene, la modalità essenziale con cui si dà al nostro vissuto al di là delle specifiche caratteristiche esteriori. Alla fenomenologia non interessa la descrizione delle singole pratiche e modalità con cui, ad esempio, è celebrato un determinato rito religioso o che caratterizzano un determinato comportamento morale, ma invece ad essa interessa descrivere e capire in che modo la coscienza intuitivamente riconosce e attribuisce a quel rito particolare la specie essenziale della religiosità o riconosce e attribuisce a quel comportamento l’essenza espressiva della moralità.
La coscienza non è vuota ma è necessariamente coscienza di qualcosa: recuperando il concetto scolastico di intenzionalità, ripreso anche da F. Brentano, maestro di Husserl, essa è definita come "coscienza intenzionale", ossia “intenzionata”, vale a dire rivolta, indirizzata ai fenomeni. I singoli fenomeni sono in se stessi casuali e contingenti ed è solo la coscienza che li interpreta e attribuisce loro un contenuto essenziale di natura universale e trascendentale. Universale perché le essenze desumibili dai fenomeni sono concepite quali strutture invarianti, costanti, ovvero quali connotati comunemente e stabilmente colti. Trascendentale giacché le essenze non derivano dai singoli particolari fenomeni ma li trascendono, li superano, in quanto in ciascuno dei diversi singoli fenomeni appartenenti a una data specie (la religiosità, la moralità, la giustizia, la bellezza, ecc.) viene dalla coscienza anzitutto afferrato non la specifica fatticità ma il senso essenziale. Innumerevoli sono, ad esempio, i tipi di cibo e svariate ne sono le sembianze, ma l’essenza del cibo, il comune vincolo normativo o struttura invariante che la coscienza intuitivamente coglie, è la “mangiabilità”, senza cui si accompagnerebbe il non senso logico e gnoseologico dell’oggetto e, quindi, la sua nientificazione, il suo non significare alcunché. Altrettanto, non cogliamo soltanto il suono di questo violino ma "il suono", la sonorità, cioè l'essenza, l'idea universale di suono; similmente, non cogliamo solo questo colore, ma anche "il colore", costituente la comune essenza tipica della specie concernente gli oggetti colorati. In ogni fatto particolare si coglie sempre un'essenza o idea universale. Quando la coscienza coglie un fatto qui ed ora, essa coglie anche l'essenza di cui quel fatto specifico e contingente è un caso particolare: questo colore è un caso particolare dell'essenza "colore"; questo suono è un caso particolare dell'essenza "suono"; questo rumore è un caso particolare delle essenza "rumore", e così via.
Si può notare come la fenomenologia risulti in parte somigliante ed in parte differente rispetto sia al kantismo che all'idealismo. La coscienza fenomenologica organizza, interpreta e conferisce senso ai dati dell'esperienza, ai fenomeni, analogamente alle forme a priori della sensibilità (spazio tempo) e alle categorie dell'intelletto su cui Kant fonda la validità della matematica e della fisica. Ma, diversamente da Kant, la coscienza fenomenologica abbraccia la totalità delle facoltà umane: non è solo intelletto (ragion pura) ma è anche volontà (ragion pratica) e sentimento (critica del giudizio). La coscienza fenomenologica inoltre, nel suo intenzionarsi, è coscienza universale come l'Io, l'Idea o lo Spirito dell'Idealismo ma, diversamente dall'Idealismo, non è produttrice della realtà bensì si pone in rapporto, si confronta, con la realtà fenomenica.
Fondatore e maggior esponente della fenomenologia, si è anticipato, è Edmund Husserl. Altri importanti esponenti sono Max Scheler, Nicolai Hartmann e, in parte, Martin Heidegger.
Come scienza del rapporto tra coscienza e fatti fenomenici, come scienza delle essenze, la fenomenologia si sviluppa al suo interno in due direzioni od orientamenti: uno di tendenza idealistica, l'altro di tendenza realistica.
Secondo l'orientamento pro-idealistico, assunto da Husserl soprattutto nelle sue ultime opere, le significanze o essenze dei fenomeni, ivi compresi sia gli oggetti di esperienza sia le istituzioni sociali (la famiglia, le organizzazioni sociali, statuali, ecc.) sia anche i valori, gli ideali, sono generate dalla coscienza stessa.
Secondo l'orientamento pro-realista, assunto da Scheler, le essenze dalla coscienza colte ed intuite hanno reale sussistenza in sé, come le idee matematiche o platoniche. Hartmann, a sua volta, assume un'impostazione prevalentemente ontologica, volta a considerare la fenomenologia soprattutto come analisi dell'essere anziché come analisi della coscienza.
Notevole è stato l'influsso della fenomenologia non solo su taluni ulteriori sviluppi della filosofia come l'esistenzialismo, ma anche sulla psicologia, sull'antropologia, sulla psichiatria, sulla morale e sulla religione.
Francesco Lorenzoni, 6 ottobre 2019
LA RIVOLUZIONE SCIENTIFICA E LE ANTICIPAZIONI DI GIORDANO BRUNO.
Per rivoluzione scientifica si intende quel lungo processo nel corso del quale, nel 16º e 17º secolo, ha avuto origine e si è quindi sviluppata la scienza moderna. Si è soliti considerare la durata di tale processo (150 anni) a partire dalla pubblicazione, nel 1543, dell'opera di Copernico "Le rivoluzioni dei corpi celesti" fino all'opera di Newton "I principi matematici di filosofia naturale", del 1687.
Le nuove caratteristiche assunte dalla scienza moderna trovano definizione metodologica soprattutto in Galileo Galilei, in Francesco Bacone nonché, successivamente, una più compiuta sistemazione con Isaac Newton.
La rivoluzione scientifica è preceduta dalla rivoluzione astronomica di Copernico e Keplero, resa possibile dall'affermarsi dell'idea secondo cui l'universo ha una struttura razionale, perciò conoscibile, e che una spiegazione semplice e unitaria al riguardo è da preferire ad una spiegazione complicata e macchinosa quale era quella che stava alla base del vecchio sistema astronomico geocentrico.
Inizialmente, astronomia, astrologia e magia erano intrecciate ma in seguito, dapprima nei paesi protestanti, l'astronomia diventa scienza autonoma, basata su nuovi metodi di osservazione empirica e di calcolo matematico che, estesi ben presto alle scienze naturali, hanno favorito l'avvento della nuova scienza.
Sia la rivoluzione astronomica sia, in maggior misura, la rivoluzione scientifica hanno comportato un cambiamento così ampio di metodi e concezioni tale da provocare un vero e proprio capovolgimento, rivoluzionario appunto, di quelli precedenti.
Cade non solo la cosmologia tolemaico-aristotelica, ma cadono inoltre idee da lungo tempo consolidate, riguardanti l'immagine dell'uomo, il lavoro dello scienziato, le relazioni tra scienza e tecnica, tra scienza e filosofia, tra scienza e religione.
Da quando Copernico, con la sua teoria eliocentrica, mette al centro dell'universo il Sole al posto della Terra, entra in crisi anche l'immagine dell'uomo basata sull'antico modello geocentrico. Anche l'uomo comincia a perdere la sua centralità nell'universo e deve trovare nuove risposte sulla sua collocazione nel mondo.
Sorge l'inquietante domanda:
se la Terra è un corpo celeste come gli altri, e non più il centro dell'universo creata da Dio in funzione dell'uomo concepito come il punto più alto della creazione, potrebbe essere allora che esistano altri uomini su altri pianeti? E, nel caso, in che consisterebbe la verità dell'incarnazione e discesa di Dio su questa Terra, per la redenzione dei suoi abitanti, in confronto ai possibili abitanti di altri pianeti? In che modo Dio potrebbe aver redento anche questi altri?
Se iniziatori e protagonisti della rivoluzione astronomica sono stati Copernico e Keplero, vale nondimeno richiamare in proposito anche la visione cosmologica di Giordano Bruno che, pur derivando da considerazioni filosofico-metafisiche anziché scientifiche, è per molti aspetti più innovativa ed avanzata delle stesse concezioni di Copernico e di Keplero.
Bruno nega e supera il concetto di universo chiuso, delimitato dalla sfera delle stelle fisse, e sostiene, invece, sia il concetto di un universo infinito e senza centro, poiché mobile cambiando il punto di osservazione, sia il concetto di una pluralità di mondi. Mentre per Copernico e per Keplero il sistema solare rimane unico, Bruno intuisce la possibilità che esistano, come effettivamente è stato scoperto, numerosi sistemi solari, numerose stelle circondate dai loro pianeti, non escludendo che molti siano abitati.
Con l'avvento della scienza moderna del tutto nuovo, si diceva, è il modo di concepire la natura nonché la conoscenza e la scienza rispetto a quello antico.
La scienza antica e medievale danno una descrizione soprattutto qualitativa e finalistica della realtà e della natura. Descrivono la realtà come appare nei suoi aspetti qualitativi esteriori, ma intendono anche scoprire, attraverso la metafisica, cosa c'è sotto l'apparenza esteriore della realtà; intendono cercare le essenze, le sostanze, le cause prime e i principi generali del reale, nonché scoprirne il fine ultimo.
Anche nella filosofia umanistica e rinascimentale rimane un’ottica in buona parte qualitativa e finalistica della natura, concepita come organismo vivente, come realtà animata che ha una sua vita ed un suo fine.
La scienza moderna vuole, al contrario, fornire spiegazioni quantitative, non limitarsi a descrivere bensì impegnarsi nel misurare i fenomeni naturali, calcolando quali gradi di relazione (di peso, di distanza, di somiglianza o differenza, di associazione o di separazione) esistono o non esistono fra di essi. Essenziale diviene quindi l’applicazione del metodo matematico. Altresì, i fenomeni sono spiegati in termini di rapporti di causa ed effetto, non contando spiegazioni di tipo finalistico. Prevale la causa efficiente e non la causa finale.
Riassumendo, tratti salienti della nuova concezione della natura sono:
1) L'oggettività. La ricerca scientifica deve essere oggettiva, osservare gli oggetti della natura in sé abbandonando ogni rappresentazione magica, finalistica, spirituale e soggettiva.
2) La causalità.
Nella natura ogni fenomeno è l'effetto di cause ben precise e niente avviene per caso. Si conosce veramente un fenomeno quando se ne scopre la causa.
3) La relazionalità.
La natura non è più pensata come insieme di "essenze", di sostanze occulte, ma come insieme di relazioni comparate e causali tra i fenomeni.
Corrispondentemente, tratti salienti della nuova concezione della scienza sono:
1) La sperimentalità.
La scienza moderna si fonda sull'osservazione dei fatti e le teorie scientifiche devono essere verificate empiricamente. Non possono esclusivamente basarsi su puri ragionamenti né, tanto meno, sui miti o sulla magia.
2) La matematizzazione.
La scienza è un sapere basato sul calcolo e sulla misurazione quantitativa dei fenomeni e deve essere capace di trasformare in formule matematiche i propri dati e i risultati.
3) L’intersoggettività.
I procedimenti e i risultati della scienza devono essere pubblici, devono essere portati a conoscenza di tutti perché ognuno possa controllare la validità delle teorie e delle scoperte. Le stesse teorie e scoperte sono sempre più il risultato della collaborazione di molti e sempre meno sono il risultato di un unico solitario scienziato.
4) La valenza anche pratica.
La validità delle teorie e scoperte consiste anche nella loro capacità di prevedere i fenomeni per poterli controllare e, ove possibile, dirigere la natura a vantaggio degli uomini.
5) L’universalità delle leggi di natura.
Scopo primo della scienza è l’individuazione delle leggi universali e necessarie che governano il mondo, operando in maniera il più possibile neutrale e disinteressata, libera da schemi e da preoccupazioni estranee di tipo etico, religioso o sentimentale.
Fonti:
Francesco Lorenzoni,
19 settembre 2017
Luca Gb
Secondo me la scienza nasce già nel medioevo, o meglio, rinasce, visto che era già nata in età ellenistica (ma scomparsa pochi secoli dopo). La scienza del '600 non la vedo come una rivoluzione ma come la logica continuazione della scienza medievale.
L'esperimento era già teorizzato e praticato da Nicola d'Oresme, Ruggero Bacone e altri, che anticiparono anche varie intuizioni galileiane e newtoniane. La matematizzazione pure la ritroviamo per lo meno nei calculatores di Oxford e in Nicola d'Oresme. Per quanto riguarda l'intersoggettivitá, le università nascono nel medioevo, non serve dire altro credo. Così come per l'aspetto pratico basti segnalare la costruzione di orologi di vario tipo.
A dirla tutta le scoperte astronomiche del '600 sono state preparate dalle dispute teologiche medievali che già avevano messo in discussione la cosmologia di Aristotele, con le sue sfere celesti, l'immobilità della Terra, ecc.
Anche la teoria dei molti mondi di Bruno era molto vecchia.
Tralasciando i numerosi sostenitori dell'antichità, l'ipotesi era stata ventilata nel medioevo da Guglielmo di Ockham, Nicola d'Oresme, papa Innocenzo V.
Per quanto riguarda il problema della redenzione degli abitanti di infiniti mondi, nel medioevo si era già posto il problema William Vorilong, che così diceva:
“Riguardo alla domanda se Cristo possa redimere gli abitanti di un altro mondo, rispondo che Luie’ in grado di fare cio’, anche se i mondi fossero infiniti. Pero’ non sarebbe serio per Lui scendere su un altro mondo per dover morire di nuovo"
Max Crudo
Vedi infatti Luigi Borzacchini in "Il computer di Ockham".
Francesco Lorenzoni
Luca Gb: non sbagli. Non va sottovalutato il carattere evolutivo, più che di rottura, della scienza e filosofia. Se si parla si "rivoluzione" è anche per trasporto linguistico, allorché si vogliano evidenziare con particolare enfasi determinati eventi.
Max Crudo
Ottimo. Aggiungo che nel 1543 viene pubblicata anche un'altra opera rivoluzionaria, De Humani Corpore Fabbrica di Vesalio. E la medicina comincia a uscire dal limbo galenico.
Giuseppe Arena
Giordano Bruno é il più grande di tutti gli altri. Egli, da grande filosofo, parte da una semplice premessa teologica e cioé, se Dio é infinito, egli non ha potuto creare che cose infinite, e non semplicemente questo mondo conosciuto e finito, ma innumerevoli altri mondi con altri pianeti, possibilmente abitati e la scienza, oggi, gli sta dando ragione. Bruno, non solo costituisce l'acme della filosofia rinascimentale, ma é l'antesignano della scienza e del pensiero moderno. Grande Bruno!
HENRI BERGSON (1859-1941) 1
Parigino, di origine ebraica, si laurea in lettere e in matematica.
In seguito si dedica alla filosofia, riscuotendo grande successo di pubblico. È stato docente di liceo e poi al College de France, conducendo peraltro una vita appartata. Nel 1928 riceve il premio Nobel per la letteratura.
Opere principali: Saggio sui dati immediati della coscienza; Materia e memoria; Introduzione alla metafisica; L'evoluzione creatrice.
È considerato tra i filosofi più importanti del suo tempo. Notevole è stato l'influsso del suo pensiero anche sulla scienza, sull'arte, sulla letteratura, sulla società. La sua filosofia si inquadra, a modo proprio, nel solco dello “Spiritualismo francese”, corrente che si sviluppa tra fine Ottocento e Novecento contro la pretesa positivistica di ridurre la vita spirituale a fatti "naturali", analizzabili col metodo scientifico e spiegabili con leggi deterministiche simili a quelle di natura. Nella convinzione dell'assoluta irriducibilità della coscienza a elemento naturale, ovvero del soggetto ad oggetto, dell’interiorità ad esteriorità, l’intento mirato è la difesa della creatività e libertà della persona umana nonché la considerazione del mondo dei valori, altrettanto reali per lo spiritualismo quanto i fatti fisici. L'originalità e peculiarità di Bergson sta nell’aver perseguito tale intento non contro ma, deliberatamente, facendo propri i risultati della scienza, senza misconoscimento dei fenomeni fisici e dell'universo materiale, grosso errore, questo, addebitato alle dottrine prettamente spiritualiste. Egli intende essere fedele alla realtà, anche a quella fisica, tuttavia secondo un’ottica non stravolta e ridotta a culto ingenuo dei "fatti" come nel Positivismo, di cui critica lo schematismo scientifico. Si propone perciò di costruire un nuovo modello di sapere filosofico, non identificato con la metafisica tradizionale, costruita su "essenze immobili", ma fondato sul concetto della centralità della coscienza, in una sintesi ricca e innovativa tra evoluzionismo spenceriano e “misticismo pragmatico”.
Il tempo della scienza e quello della coscienza
Proprio per la sua fedeltà alla realtà, Bergson da giovane si entusiasma per la teoria positivistico-evoluzionistica di Spencer. Sennonché si accorge che il Positivismo non mantiene affatto la sua promessa di fedeltà ai fatti, come nel caso della trattazione del problema del tempo. Dà luogo pertanto alla sua celebre distinzione tra tempo della scienza e tempo della coscienza.
Osserva che il tempo della scienza e della meccanica è concepito come una serie di istanti (di unità di misura) uno accanto all'altro ed ognuno identico all'altro. È un tempo spazializzato, espresso in termini di movimento di un oggetto in un certo spazio. È altresì un tempo reversibile nel senso che possiamo tornare indietro e ripetere infinitamente la misurazione temporale. Ma queste caratteristiche di spazialità e reversibilità del tempo della scienza non riescono minimamente rendere conto del tempo della coscienza.
Il tempo della coscienza, la cui peculiarità è da Bergson definita "durata", è ben altro rispetto al tempo della scienza: è il tempo interiore, che sentiamo dentro di noi come continuo fluire e scorrere di istanti, di momenti, non uguali ma diversi fra loro secondo lo stato d’animo, non separabili e non divisibili gli uni dagli altri, anzi compenetrati, tali che crescono uno sull'altro. Nell’uomo non si può porre il tempo senza una coscienza che lo percepisca. Ed è un tempo irreversibile: non si può tornare indietro perché è tutt’uno con la storia della nostra coscienza che procede incessantemente in avanti. Viene avvertito come continua successione dei nostri stati d'animo, che si fondono tra loro e plasmano la coscienza stessa, la quale si forma, cresce e cambia in base alle più varie esperienze maturate. Sicché il tempo della coscienza è durata che conserva tutti gli stati di coscienza, quelli presenti e trascorsi ma anche quelli inconsci, e che contemporaneamente cresce continuamente su di sé. È come un gomitolo di filo, mentre il tempo della scienza è come una collana di perle. Certo, il tempo spazializzo della scienza, quantitativo e misurabile, funziona bene per le finalità pratiche, ma la scienza della natura e i suoi metodi sono del tutto inadeguati per la comprensione dei dati della coscienza.
Sull'idea di durata, quale caratteristica tipica della coscienza, Bergson fonda la libertà della coscienza stessa nonché la propria critica al determinismo per la presunzione di spiegarne meccanicamente la vita. Affronta di petto il problema del rapporto tra libertà della coscienza e necessità predeterminata dei comportamenti, chiedendosi se l'uomo è libero oppure se le sue azioni sono il risultato di meccanismi vincolanti e necessitati. Respinge al riguardo non solo il determinismo ma anche la dottrina del libero arbitrio. Entrambe le concezioni sono giudicate errate perché applicano alla coscienza concetti che sono invece ad essa esterni. I deterministi cercano le cause determinanti dell'azione negli eventi passati mentre i sostenitori del libero arbitrio pongono la volontà come causa della libertà, ma entrambi presuppongono un'idea di coscienza come somma di atti distinti ed irrigiditi, siano questi i condizionamenti degli avvenimenti accaduti oppure i singoli atti di volontà. La coscienza, viceversa, non è fissa e cristallizzata; è puro scorrere creativo che si rinnova continuamente e imprevedibilmente. Serba tutte le tracce del proprio passato in base a cui, storicamente, viene a costruirsi e a definirsi, secondo un processo perpetuo di crescita e sviluppo. In essa non esistono mai eventi identici derivanti dall'esterno o da una specifica scelta della volontà poiché l'azione e il comportamento umani discendono dalla vicenda complessivo lungo cui la coscienza è venuta a maturarsi, derivano dall'intera storia interiore di ciascuno, in quanto tale soggettiva, non oggettivamente predeterminabile. La durata per sua natura non è scientificamente definibile; sconfina nel passato, attualizzando ed affastellando ricordi e sensazioni percepite, e si proietta nel futuro delle azioni e dei progetti comportamentali soggettivamente presi in conto. La scienza, diversamente, considerando eminentemente l’aspetto quantitativo, suppone un tempo scandito da un ordine geometrico e spaziale fatto di momenti distinti ma tutti uniformemente misurabili. L’individuo vive invece il tempo secondo un criterio qualitativo: certi momenti sono, per la coscienza che li vive, fulminei, altri possono durare un’eternità (un'ora di sofferenza dura per noi molto di più di un'ora di piacere). Il passato remoto può essere immediatamente e significativamente attualizzato, reso presente e vivo per l’individuo, e il passato prossimo, per contro, assolutamente dimenticato. Dipende dalla qualità che i ricordi hanno dal punto di vista emotivo coscienziale. La scienza non è in grado di cogliere questa dimensione perché, sostanzialmente, tratta il tempo come se fosse spazio. Ma lo spazio temporale è un concetto astratto, una rappresentazione teorica, una sorta di espediente cui ricorre l’intelligenza per disporre ed organizzare i dati acquisiti lungo il processo conoscitivo. E anche il tempo della scienza, in quanto calcolabile, è assunto come elemento quantitativo omogeneo, divisibile secondo costanti unità di misura. Sennonché, in opposizione al modello scientifico di tempo, si pone il tempo proprio della umana esistenza, non misurabile, irriducibile a quantità. È vero che spesso i nostri atti sono abitudinari, per cui sono in tal senso meccanici, analizzabili e prevedibili come i fenomeni esterni, talché in essi non siamo liberi. Quando però l'atto di volontà deriva dallo sciolto fluire della coscienza esso si presenta come qualcosa di continuamente nuovo e creativo. In questo senso è atto libero, di una libertà imprevedibile e indefinibile perché dipende, di volta in volta, da come in quel momento l'intera coscienza è venuta a maturare. Una libertà indefinibile perché il definirla significherebbe irrigidirla, cristallizzarne lo slancio per sottoporlo a statici criteri di misurazione. Ma, se imprigionata, la coscienza cessa di essere vita per diventare morte e il divenire si trasforma in divenuto, muta natura non appena è sottoposto ad indagine.
Francesco Lorenzoni, 14 agosto 2019
IL NEOIDEALISMO ITALIANO: BENEDETTO CROCE E GIOVANNI GENTILE
Chiamasi “Neoidealismo Italiano” il movimento di pensiero, sorto in Italia nel primo Novecento, caratterizzato dalla ripresa della filosofia hegeliana, peraltro riformulata, nonché da una critica radicale al positivismo, congiuntamente ad una critica ma anche da una riflessione sul marxismo. Ha in Benedetto Croce e Giovanni Gentile i maggiori esponenti.
BENEDETTO CROCE (1866-1952) 1
Di famiglia agiata, può dedicarsi tranquillamente ai suoi studi. Fonda insieme a Gentile la rivista "La critica". È stato senatore e anche Ministro dell'istruzione. Antifascista e antimarxista, dopo la guerra è stato Presidente del partito liberale e ha partecipato all'Assemblea costituente.
Opere principali: Logica come scienza del concetto puro; Estetica come scienza dell'espressione e linguistica generale; Teoria della storia e storiografia; La storia come pensiero e come azione.
La filosofia dello Spirito e riformulazione della filosofia hegeliana
Inizialmente Croce, nell'opera "Materialismo storico ed economia marxista", indirizza i propri interessi verso il marxismo, giungendo peraltro a conclusioni critiche. Individua come errate le tesi fondamentali della filosofia marxista, ovvero: la teoria del plus-valore, che non tiene conto della domanda e dell'offerta del mercato quali fattori determinanti nella formazione dei prezzi delle merci; il materialismo storico (secondo cui la struttura economica determina la sovrastruttura ideologico-culturale della società), che giudica non già una vera filosofia della storia ma una semplice interpretazione storica dal punto di vista economico; le limitazioni dell'analisi economica marxista, che si è occupata di una sola forma economica, ossia del capitalismo, e non del fatto economico in sé. Riconosce invece l'importanza, ma non esclusiva, dei fattori economici nello sviluppo della storia. Negativa è comunque, nel complesso, la valutazione che Croce dà del pensiero politico di Marx, visto come un "Machiavelli del proletariato".
Dopo l'iniziale attenzione al marxismo e le critiche espresse in merito, nell'opera "Ciò che è vivo e ciò che è morto della filosofia di Hegel", Croce sente il bisogno di risalire alle fonti della sinistra hegeliana. Si dedica pertanto alla filosofia di Hegel, accettandone alcune tesi ma respingendo e modificandone altre.
Di Hegel condivide la concezione idealistico-immanentistica, secondo cui la realtà più autentica e profonda è lo Spirito, il pensiero in generale, mentre gli enti finiti (gli oggetti, i singoli uomini e gli eventi storici) ne sono solo manifestazioni e da esso derivano. Lo Spirito è movimento, processo continuo che, nella misura in cui si rivela all’umano conoscere, produce gli enti finiti, altrimenti per noi insistenti se non conosciuti, percepiti, ma destinati ad essere poi riassorbiti nello Spirito medesimo, che è totalità infinita e assoluta la quale niente lascia fuori da sé. Ogni ente finito, così, è solo un momento della totalità dello Spirito, del quale è partecipe in collegamento con tutti gli altri enti finiti. Di conseguenza il finito in sé non esiste; è solo realizzazione provvisoria dello Spirito nell’inscindibile connessione di fondo del finito con l’infinito.
Di Hegel Croce apprezza anche il principio secondo cui lo Spirito è colto, compreso, dalla riflessione filosofica attraverso il concetto puro, universale e concreto: puro perché non è intuizione o sentimento, ma è fondato sulla logica; universale perché trascende, supera, le singole percezioni e neppure coincide con i concetti ordinari, che sono semplici generalizzazioni e astrazioni da un complesso di percezioni e sensazioni simili, mentre il concetto universale, invece, si identifica direttamente con l'Idea, con la razionalità; concreto perché coglie la realtà nelle sue singole determinazioni empiriche, tuttavia non esterne e indipendenti, bensì espressioni della totalità e realtà infinita dello stesso Spirito assoluto, da cui nascono e del quale fanno parte.
Con tali assunti Hegel superava la concezione sia di quanti riducevano gli opposti ad una semplice "coincidentia oppositorum" (interpretando il puro essere come un puro nulla), opposti che in tal modo venivano appiattiti e soppressi, sia di quanti li mantenevano dualisticamente contrapposti e separati senza alcuna possibilità di sintesi. La realtà hegeliana, invece, deriva sempre da una sintesi di opposti e proprio per questo non si sfascia, sviluppandosi anzi eternamente nella serie delle sintesi. Nell’universale-concreto, nella sintetica unità degli opposti, è individuato il nuovo e vero principio di identità.
Anche per Croce la filosofia è filosofia idealistica dello Spirito poiché né le cose materiali né gli spiriti finiti, le singole coscienze umane, hanno realtà propria in quanto prodotti, entrambi, dello Spirito assoluto. Come in Hegel, anche filosofia crociana dello Spirito è immanentistica: lo Spirito non è trascendente, distinto e separato dal mondo delle cose e degli uomini, ma è dentro il mondo; è processo che si realizza e si manifesta nel mondo animandolo e sviluppandolo. E’ altresì filosofia storicistica perché la realtà dei fatti umani altro non è che realizzazione dello Spirito, il quale attraverso la storia umana si manifesta e dialetticamente procede. Da questa impostazione immanentistica e storicistica discende, al pari di Hegel, la critica da Croce rivolta ad ogni filosofia fondata sia sulla trascendenza sia su essenze statiche e precostituite, anche se immanenti come nel caso della sostanza spinoziana, poiché lo Spirito (o Idea o pensiero) della filosofia idealistica non è sostanza immobile ma perpetuo dinamismo che si svolge storicamente nel mondo.
Croce, viceversa, si distacca dal pensiero hegeliano nel rifiutarne l’esclusività del processo dialettico posto a spiegazione del divenire della realtà. L'errore imputato ad Hegel è di non aver capito che la realtà non è fatta solo di opposti (tesi e antitesi) che poi trovano la loro sintesi, ma anche di "distinti", di differenziazioni che non si risolvono in una sintesi, vale a dire di ambiti tra essi non in unitaria progressiva sequenza dialettica, seppur collegati. Diversamente da Hegel, che non ha riconosciuto i distinti trattandoli come opposti, non è l'opposizione che per Croce bisogna principalmente scoprire nella vita dello Spirito ma piuttosto la distinzione. Da tale spunto egli sviluppa la teoria definita, appunto, “dialettica, o nesso, dei distinti”.
Francesco Lorenzoni,
15 settembre 2018
GIOVANNI GENTILE (1875-1944) 1
Studente alla Scuola Normale di Pisa, è poi divenuto docente all'università di Palermo, di Pisa e di Roma. È stato senatore e ministro dell'istruzione, portando a termine la riforma della scuola iniziata da Croce. Aderisce al fascismo, illusoriamente considerato come realizzazione, da parte dello Spirito, dello Stato etico con annesso superamento dell'individualismo. Per ostinata coerenza, dopo la caduta del fascismo aderisce anche alla ricostituita Repubblica Sociale di Salò. Ciò gli è probabilmente costato la vita: è stato ucciso a Firenze da un'azione partigiana.
Opere principali: L'atto del pensare come atto puro; La riforma della dialettica hegeliana; La teoria generale dello spirito come atto puro; Il sistema della logica.
L'attualismo
Alla filosofia di Gentile è dato il nome di "attualismo", contrassegnato da un'impostazione di soggettivismo ed immanentismo assoluti.
Si ispira alla dialettica di Hegel, tuttavia riformulata e corretta. In particolare, ravvisa due forme di dialettica:
1. quella antica, di tipo platonico, definita come dialettica del pensato perché considera le idee, o analoghe, come già date e predeterminate, indipendenti dal pensiero e sussistenti per loro conto in un mondo sovrasensibile, cosicché il pensiero, discendendo da tali idee o concetti puri, non è un pensare originale ma derivato, il riflesso di idee esterne, antecedenti all’atto del pensare;
2. la “dialettica del pensare”, o dialettica moderna, per la quale non esistono realtà, idee, concetti e verità già dati e predeterminati, esterni e anteriori rispetto al soggetto pensante.
Gentile riconosce ad Hegel il merito di aver compreso che la realtà non si fonda su una sostanza o su principi statici, essendo invece in continuo divenire. Tuttavia, aggiunge, la dialettica di Hegel non è ancora arrivata alla sua perfezione perché in essa rimangono residui della vecchia dialettica, elementi di staticità che contraddicono la concezione della realtà come perpetuo rinnovarsi. L'errore di Hegel è di aver ancora concepito la dialettica come dialettica del pensato, come un insieme di regole che sussistono prima del pensare e che, anzi, guidano e vincolano dall'esterno il pensare medesimo. Il pensare invece, ribatte Gentile, non si svolge secondo regole prestabilite ma è esso stesso che, nell’"atto" in cui pensa, liberamente crea le proprie regole, che può anche cambiare e che non sono perciò predeterminate. Anche la verità non è qualcosa di statico, di predefinito e preesistente al pensiero. La verità, piuttosto, è quella che il pensiero crea nel momento in cui pensa. Da ciò il nome di "attualismo" attribuito alla filosofia di Gentile.
Della dialettica hegeliana Gentile salva la sola filosofia dello Spirito in quanto più propriamente dialettica del pensare, del pensiero pensante. Come in Hegel, anche per Gentile la realtà autentica e la verità esistono esclusivamente nello Spirito, nel pensiero, non essendoci nulla al di fuori di esso. Ma, a differenza di Hegel, dichiara che la verità e la realtà vive sussistono soltanto nel momento in cui si pensa poiché ciò che già è stato pensato è ormai irrigidito, già fissato in se stesso. La realtà autenticamente vivente e diveniente sta solo nell’atto del pensare in capo al Soggetto pensante. Non solo non vi sono oggetti esterni ma neppure vi sono altri distinti soggetti pensanti di sorta, dato che questi possono essere riconosciuti come "altri" solo nel momento in cui si pensano, venendo quindi anch'essi, per ciò stesso, a far parte del medesimo, unitario atto del pensare. L'atto del pensare, o pensiero in atto, del Soggetto pensante è chiamato da Gentile "Soggetto trascendentale" o "Io universale e assoluto": soggetto in quanto univocamente identificato con la coscienza dell'umanità nella sua complessiva facoltà di pensare e di conoscere; trascendentale perché il pensiero in atto non è quello del singolo soggetto empirico ma quello dello Spirito, che in quanto tale trascende i singoli individui, le singole coscienze individuali. Non ci sono dapprima gli oggetti che solo successivamente possono essere pensati; essi sono, anzi, il prodotto dell'atto del pensare, ovvero del Soggetto trascendentale il quale crea il proprio oggetto nel momento in cui lo pensa e che, nel pensarlo, crea e rinnova anche se stesso come pensiero in atto (autocreazione). Pertanto, ricreando sempre nuove realtà, ancorché trascorse, ormai morte e superate, non esistono oggetti se non nell’istante in cui vengono pensati o ripensati. Per tale carattere assoluto e a priori del Soggetto trascendentale la filosofia gentiliana è chiamata altresì "soggettivismo assoluto".
Se lo Spirito, il Soggetto trascendentale, trascende, sovrasta e rinnova, nel pensarli o ripensarli, tutti i singoli oggetti e soggetti empirici, esso non è però concepito come trascendente, distinto e al di sopra del mondo, ma come immanente nel mondo e nell'umanità. Non è il platonico mondo ultrasensibile delle idee e neppure è il Dio creatore delle religioni. Perciò la filosofia di Gentile è definita anche come "immanentismo assoluto". Il Soggetto trascendentale, lo Spirito, è l'Intelligenza, il Pensiero, che agisce dentro il mondo e nella storia. Nel produrre la realtà pensandola, il Pensiero, in quanto Spirito assoluto, non è condizionato da alcunché, è del tutto libero. I pensati, i singoli oggetti e le singole idee, una volta generati, non sono invece liberi ma necessitati poiché, se attualmente non ripensati, rimangono statici, immodificabili, non possono essere diversi da quel che sono laddove il Pensiero in atto, in forza della propria libertà, potrebbe anche non riprodurli o riprodurli in modo diverso.
Molti per contro, è da far presente a titolo di rilievo, non concordano con siffatto radicale assolutismo, come pure con consimili concezioni idealistiche. Ribadiscono viceversa l’esigenza di relativizzare, puntualizzando che tutt’al più solo “per noi”, ma non in assoluto, può valere il singolare asserto che gli oggetti esistono solo allorquando ne sia in corso il pensarli. E del resto anche i pensati, ribattono, sono pur partecipi come tali della sfera del pensiero.
Francesco Lorenzoni, 26 settembre 2018
GIOVANNI GENTILE (1875-1944) 2
I momenti dialettici dello Spirito
Secondo la concezione idealistica, lo Spirito è movimento, è processo di sviluppo dialettico della realtà. Peraltro, Gentile individua i momenti dialettici in termini diversi rispetto ad Hegel:
1. la tesi è costituita dal soggetto pensante, puro pensiero, pura facoltà di pensare;
2. l'antitesi è costituita dall'oggetto, che il soggetto contrappone a sé come coscienza di qualche cosa d'altro da sé: non è il pensiero pensante ma il pensato;
3. la sintesi è il momento in cui il soggetto pensante riconosce (autocoscienza) i pensati, cioè gli oggetti nonché tutta la realtà, come propri costrutti: la sintesi è unità di soggetto e oggetto.
Anche qui, come in genere nella dialettica idealistica, la tesi e l'antitesi non hanno valore reale bensì solo ideale, logico-concettuale. La vera realtà, invece, consiste solo nell’avvicendarsi delle sintesi, ove soggetto pensante e oggetto pensato sono tutt’uno. Il processo dialettico è la spiritualizzazione (il diventare spirito) della realtà, che cessa pertanto di apparire come insieme di oggetti opposti al soggetto ma viene riconosciuta come procreata dal soggetto stesso: tutto è riportato all'autocoscienza. In ciascun momento in cui viene spiritualizzato, in cui viene pensato, ogni oggetto diventa partecipe dello Spirito. Lo Spirito è processo che crea al proprio interno la molteplicità degli oggetti e continuamente li oltrepassa mediante incessanti sintesi progressive. In questo senso la dialettica gentiliana è più simile a quella di Fichte che a quella di Hegel. Come per Fichte, la realtà autentica è il prodotto dei moti del pensiero, che tuttavia non giungono mai a termine poiché il processo procede indefinitamente secondo un andamento lineare infinito anziché secondo un andamento circolare come in Hegel.
La dialettica di Gentile spiega anche l'errore e il male. Essi sono solamente antitesi in corso di superamento per raggiungere la verità e il bene e perciò, dato che l'unica realtà consiste nelle sole sintesi operate dal pensiero in atto, essi non sono reali. Il pensiero in atto è in sé sempre verità, positività. L'errore, il male, il dolore sussistono nel pensiero in atto soltanto come momenti superati. Solo dopo essere stati oltrepassati vengono riconosciuti come tali ma allora, in quanto sorpassati, non sono più qualcosa di negativo perché la conoscenza dell'errore e del male è sempre verità e bene. Neppure la morte propriamente esiste giacché riguarda solamente l'io empirico, per cui essa, in realtà, è un ritorno all'Io trascendentale.
Arte, religione, filosofia e scienza
Da Gentile è individuata una peculiare corrispondenza fra i tre momenti del processo dialettico dello Spirito e gli ambiti della cultura:
1. al momento del soggetto (tesi) corrisponde l'arte;
2. al momento dell'oggetto (antitesi) corrisponde la religione;
3. al momento dell'unità di soggetto ed oggetto (sintesi) corrisponde la filosofia.
Come tesi, l'arte è il momento del soggetto pensante, l'ambito della pura soggettività in cui il soggetto prevale; il mondo dell'arte è un mondo fantastico che si presenta come stato d'animo soggettivo; non possiede realtà oggettiva. A differenza di Croce, per Gentile l'arte non è intuizione conoscitiva, benché elementare, non ancora logica, ma è sentimento, il sentimento di quel soggetto che è l'artista e il sentimento di quegli altri soggetti che sono le persone che fruiscono e ammirano le opere d'arte. Anzi, l'arte non è un qualunque sentimento ma è quel sentimento di infinito che è perpetuo slancio e tensione verso ogni forma di realtà, soprattutto verso lo Spirito. Poiché manifestazione della libera creatività del pensiero artistico, l'arte è autonoma sia dalla morale sia da ogni condizionamento storico-culturale.
La religione è l'antitesi dell'arte; come nell'antitesi del processo dialettico, essa è l'ambito in cui prevale l'oggetto, in questo caso Dio, oggetto sommo. Nella religione il Pensiero, lo Spirito, non è avvertito come forza e attività immanente nel Soggetto trascendentale; il soggetto è invece dimentico di se stesso e si annulla in un oggetto concepito come assoluto, come trascendente ed adorato quale Dio. La religione è perciò considerata negazione della libertà e creatività del Pensiero ed è intesa come misticismo, come annullamento dell'uomo in un oggetto esterno. Il soggetto concepisce la creazione non come propria autocreazione ma come opera di un entità esterna. Altrettanto, la religione concepisce la conoscenza non come umana comprensione dell'inscindibile unitarietà di oggetto e soggetto, allorché giunge all'autocoscienza, ma come rivelazione e illuminazione divina donata all’uomo. Parimenti, la religione concepisce il bene non come realizzazione della volontà soggettiva ma come grazia che l'oggetto sommo -Dio- offre al soggetto. Tuttavia la religione, prosegue Gentile, pur spingendo l'uomo ad annullarsi di fronte al suo Dio, ha il merito di fargli sentire dentro di sé il senso dell'eterno. Si può notare l'analogia con Feuerbach: per entrambi è l'uomo ad aver creato Dio e non viceversa; per entrambi Dio va ricercato nell'uomo: per Gentile nella sfera teoretica (del conoscere umano), per Feuerbach in quella antropologica (della natura umana).
La filosofia, corrispettiva alla sintesi dialettica, è l'ambito dell’unificazione di soggetto e oggetto. Scopre che tutta la realtà è creata dal pensiero in atto e che nulla vi è fuori di esso. Di conseguenza non ha senso parlare di un soggetto (il pensiero) e di un oggetto (il pensato) separati, perché l’oggetto altro non è che atto del pensiero nel momento in cui lo pensa e che, con ciò, lo genera. La filosofia supera pertanto sia l'individualismo eccessivo dell'arte, cioè la prevalenza del soggetto, sia la prevalenza e la separazione dell'oggetto (Dio) dal soggetto quale si ritrova nella religione. La filosofia riconosce che la realtà autentica e assoluta è invece il solo Soggetto trascendentale, lo Spirito umano pensante. Ancor prima di coincidere con quella dei filosofi, la filosofia coincide con la vita stessa, col pensiero dell'uomo, con la sua intelligenza che pone e risolve problemi. L'arte e la religione sono invece inattuali perché non sono pensiero in atto; sono momenti astratti che divengono concreti solo quando diventano filosofia. "Ogni uomo, scrive Gentile, non può mai né poetare (essere artista) né adorare (credere in Dio) senza pensare". L'arte nella sua purezza è in se stessa inafferrabile tant'è, sottolinea Gentile, che nel momento in cui il sentimento artistico viene espresso esso cessa di essere arte per diventare pensiero e, quindi, filosofia. Anche la religione nella sua purezza è inafferrabile perché il suo oggetto (Dio) esiste solo se c'è il soggetto (l’uomo) che lo pensa e che, quindi, fa filosofia. L'inattualità dell'arte e della religione si attualizza solo col loro morire come tali, diventando filosofia.
La scienza, a sua volta, è collocata da Gentile in una posizione intermedia tra l'arte e la religione. Oscilla tra la soggettività dell'arte, poiché il punto di vista dello scienziato è pur sempre soggettivo, e l'oggettività della religione, poiché persuasi che le teorie e le leggi della scienza possiedano un valore oggettivo. Sta di fatto che in Gentile la scienza non ha neppure quella validità parziale attribuita all'arte e alla religione perché di esse possiede i limiti senza condividerne le qualità. La sottovalutazione della scienza da parte di Gentile, come pure da parte di Croce, ha condizionato a lungo la cultura italiana nel privilegiare le discipline umanistiche rispetto a quelle scientifiche.
Francesco Lorenzoni,
29 settembre 2018
GIOVANNI GENTILE (1875-1944) 3
La polemica con Croce
Similmente a Gentile, anche Croce considera realtà autentica solo quella che risulta dal processo dialettico dello Spirito allorquando, nella sintesi, si realizza l'unità di soggetto e oggetto. Peraltro, s’è visto, differenziando tra attività teoretica e pratica, Croce discerne nello Spirito quattro categorie distinte (l'arte, la logica o filosofia, l'economia e la morale). Gentile, viceversa, non accetta la teoria crociana dei "distinti". Su tale questione sorge anzi un'accesa polemica fra i due filosofi che prima avevano collaborato a lungo insieme. Per Gentile lo Spirito è unico, è unità indistinta: non esistono in esso, ribatte, attività e categorie distinte perché unico è lo Spirito che pensa (attività teoretica) e che agisce (attività pratica); quando pensa agisce e quando agisce pensa. Esiste solo un'unica categoria che è l'atto del pensare, ovvero il pensiero che pensa e che, riflettendo su se stesso, si autoriconosce come realtà unica e assoluta. Scrive Gentile: “Io non sono mai io senza essere tutto quello che penso; e quello che penso è sempre unico perché unico sono io”. I quattro distinti crociani sono sempre assorbiti nell'unità dell'Io universale. La Coscienza, il Pensiero, lo Spirito dell'umanità , conclude, è uno solo; non vi sono spiriti dell'umanità plurimi perché unica è l'umanità stessa.
Filosofia, storia della filosofia e storia
Croce e Gentile, come pure Hegel, convengono invece sull'identità di storia e filosofia e sull'identità della filosofia con la storia della filosofia. Se tutta la storia della realtà è il prodotto della storia del pensiero, cioè dello Spirito, e se la storia del pensiero è la filosofia, allora storia e filosofia coincidono: lo Spirito si realizza nella storia e la storia è la realizzazione dello Spirito. Altrettanto, se la filosofia è lo studio della storia dello Spirito man mano che esso diviene e si sviluppa, allora la filosofia coincide con la storia della filosofia. Non c'è filosofo che abbia arrecato una filosofia definitiva poiché la filosofia progredisce continuamente lungo la sua storia.
Tuttavia l'identità di storia e filosofia è da Gentile concepita in maniera più estrema rispetto a Croce. Egli non distingue, come in seguito farà Croce, tra storia come pensiero (il pensiero storiografico che studia la storia) e storia come azione (le azioni storiche nel momento in cui sono compiute dagli uomini), perché è convinto che i fatti storici sono reali solo nel pensiero, solo in quanto sono pensati. A chi gli obietta che c'è contraddizione quando, da un lato, si considera che lo Spirito è storia poiché nella storia si realizza e quando, dall'altro lato, si considera che esso non è invece storia poiché eterno, Gentile risponde che è vero che lo Spirito si realizza nella storia, ma è altrettanto vero che il tempo storico, ogni tempo, passato, presente e futuro, è contestualmente presente nell'eternità dello Spirito. Nell'eternità non c'è passato e futuro, ma ogni tempo è in essa co-presente.
Lo stesso concetto secondo cui la storia è sempre storia contemporanea, già formulato da Croce, assume in Gentile un senso ancora più forte. Allorquando i fatti storici sono pensati, asserisce, essi sono sempre rivissuti dal pensiero che li pensa come attuali, sono sempre considerati e interpretati secondo i bisogni, le domande e le aspettative della contemporaneità. Dante, per fare un esempio, risulta vivo ancor oggi perché leggendo il suo poema, e quindi pensandolo, lo facciamo nostro e lo interpretiamo secondo la nostra sensibilità allo stato presente.
Lo Stato etico
Nelle opere "Fondamenti della filosofia del diritto" e "Genesi e struttura della società", Gentile affronta i temi della morale, del diritto, della politica, della società e dello Stato.
Visto che per Gentile nessuna distinzione è possibile tra attività teoretica e attività pratica, egli spiega la morale e il diritto non già in termini di prodotti dell’agire pratico, come in Croce, bensì attraverso la dialettica, ovvero attraverso la contrapposizione di volente e voluto, perfettamente corrispondente a quella di pensante e pensato: il pensiero come infinita attività creatrice è parimenti infinita volontà di creare. La moralità è il volente, è volontà del bene, cioè creazione del bene nell'atto di volerlo; il diritto è il voluto, non è più volontà in atto ma volontà trascorsa, ossia ciò che la volontà del bene è divenuta quando realizzata. Il diritto, vale a dire, è l'insieme delle norme che regolano il bene sociale che si è voluto. La moralità (volere il bene) si basa sulla libertà; il diritto (le norme volute) si basa sull'obbligo di rispettarlo, anche con l'uso della forza. Ma tale contrasto è per Gentile più apparente che reale perché il voluto, cioè il diritto, è proprio ciò che vuole il volente, ossia la moralità stessa, non quella individuale, egoistica, ma quella sociale, altruistica.
Gentile rifiuta pertanto la distinzione tra privato e pubblico e la conseguente necessità di porre limiti all'azione dello Stato. Tale distinzione non può sussistere se l'unica autentica realtà non è quella dei singoli individui empirici ma quella dello Spirito trascendentale, lo Spirito dell'umanità. La vera democrazia, quindi, è quella che non pone barriere allo Stato ma che ne riconosce la superiorità sui cittadini. Ancor più di Hegel, Gentile teorizza e sostiene in tal modo lo "Stato etico", così denominato poiché, in forza della propria superiorità, intende regolare non solo la vita pubblica ma anche la vita etica, la morale privata dei cittadini. Come in Hegel, ed anche in Rousseau, anche per Gentile lo Stato etico è la realizzazione della volontà universale dello Spirito. Senza vincoli di sorta al di sopra di sé, esso pretende obbedienza. Un’obbedienza che non è reputata in contrasto con la libertà giacché Gentile identifica la libertà non già negli egocentrismi individuali bensì nello Stato medesimo, sintesi di moralità, basata sulla libertà, e di diritto, basato sull'obbligo di rispettarlo. Solo lo Stato garantisce l’unificazione tra gli interessi individuali e i doveri che impone la società; in esso i cittadini superano l’individualismo e sono condotti ad attuare la volontà e il bene universale. Nondimeno, sia detto, resta per contro opponibile la contestazione dello Stato etico quale già mossa nei confronti di Rousseau e di Hegel, contestazione che vede nello Stato etico i prodromi dei totalitarismi e autoritarismi.
Avverso al sindacalismo, perché giudicato non in grado di eliminare la contrapposizione tra Stato e sindacati, in Gentile lo Stato etico ha una struttura corporativa, impostata sul complesso delle varie corporazioni di lavoratori. Poiché non tutti i lavori sono uguali, ciascun lavoratore appartiene ad una sua propria distinta categoria o corporazione. Ogni corporazione ha interessi specifici, differenti da quelli delle altre, ma nel loro insieme le diverse corporazioni sono chiamate a trovare un'intesa nel superiore interesse dello Stato. Lo Stato è tenuto a considerare i particolari interessi delle varie categorie di lavoratori, tuttavia in misura equilibrata stabilendo un proporzionato riconoscimento per ognuna. Il cittadino non partecipa direttamente alla vita dello Stato, ma vi partecipa indirettamente attraverso la corporazione cui appartiene. Gentile è parimenti contrario sia allo Stato liberale, giudicandone del tutto astratte e formali, in ragione del proclamato primato statuale, le libertà individuali sostenute, sia al socialismo-comunismo, poiché fa leva sulla lotta di classe e non sul comune interesse nazionale.
Proprio in base a tali ambigue concezioni stataliste Gentile finisce con l’aderire al fascismo, fornendo ad esso una giustificazione ideologica. Giudicando la società italiana troppo individualista, nutre ingenua fiducia nel fascismo, considerato fautore di un ideale collettivo non basato sui diritti individuali ma, appunto, sulle corporazioni.
La pedagogia e la riforma della scuola
In conformità alla sua filosofia che afferma la sintesi di soggetto e oggetto all'interno dello Spirito, anche per quanto riguarda la pedagogia Gentile sostiene, parimenti, l'identità tra educatore ed educando. Ogni forma di insegnamento deve comportare una profonda e reciproca intesa tra insegnante e allievo. L'insegnante deve di volta in volta adattarsi all'allievo e l'allievo all'insegnante. Non esiste quindi un metodo didattico unico e predeterminato per ogni materia e per ogni insegnante. In particolare, è rifiutato il metodo d'insegnamento di origine anglo-americana, valutato come riduttivo del processo educativo a tecniche didattiche.
Sempre in conformità alla propria filosofia, che asserisce l'identità della filosofia con la storia della filosofia, con la sua riforma della scuola del 1923 Gentile sostituisce lo studio della filosofia per problemi, per singoli temi omogenei, con quello della storia della filosofia. Altrettanto dicasi per le altre discipline, che fonda anch'esse sullo studio della relativa storia (storia della letteratura, dell'arte, della lingua, ecc.). Secondo la mentalità idealistica, che sottovaluta le scienze, considera il liceo classico, riservato ai più intelligenti, istituto scolastico superiore alle altre scuole scientifiche e tecniche.
Francesco Lorenzoni,
3 ottobre 2018
FRIEDRICH NIETZSCHE (1844 1900) 1
Di nazionalità tedesca, è stato docente di filosofia classica all'università di Basilea dalla quale tuttavia, dopo qualche anno, si dimette per motivi di salute e, soprattutto, di carattere, per andare a vivere un'esistenza errabonda tra Svizzera, Italia e Francia meridionale.
È stato anche colpito da episodi di malattia mentale, alla fine inesorabilmente aggravatisi.
Di temperamento irrequieto, non stabilisce legami costanti né con persone né con luoghi.
Agli inizi ammira la filosofia di Schopenhauer, ma in seguito la respinge. Stringe amicizia col musicista Richard Wagner, nella cui arte vede uno strumento di rigenerazione, ma successivamente ne rimane deluso poiché rivelatosi ai suoi occhi un istrione desideroso solo di successo mondano.
Opere principali:
Nascita della tragedia; La genealogia della morale; Umano, troppo umano; La Gaia scienza; Così parlò Zarathustra.
Lo stile è volutamente asistematico e il linguaggio metaforico e aforistico.
Il pensiero di Nietzsche è in effetti del tutto particolare ed originale, per cui non è facilmente collocabile all'interno di una corrente filosofica: per alcuni aspetti è antipositivista e per altri anticipa temi che saranno sviluppati dalla filosofia esistenzialista. In generale persegue un'impostazione antidealistica, come Schopenhauer e Kierkegaard, definita "irrazionalistica" in opposizione al razionalismo cui l'idealismo intendeva richiamarsi. In verità dette posizioni irrazionalistiche non sono tanto contro la funzione e l'importanza della ragione in sé quanto piuttosto contro un certo tipo di razionalismo che, attribuendo rilievo esclusivamente alla ragione, finisce col trascurare l'importanza anche delle passioni, degli istinti, dell'inconscio.
L'intera opera nietzschiana è un tentativo di comprendere e descrivere l'epoca moderna, per giungere alla drammatica constatazione della scomparsa di tutti i principi e valori tradizionali, sia culturali che morali, religiosi ed estetici: si tratta di principi e di valori, rileva Nietzsche, che non valgono niente. Da ciò l’appellativo di "nichilismo" attribuito alla sua filosofia.
Per contrapposizione, è da Nietzsche proposta una nuova cultura di stampo "eroico" e un nuovo modello di uomo. L'uomo quale descritto e pensato dalla metafisica e dalla morale tradizionali, egli proclama, deve essere superato, deve acquistare una nuova fede in se stesso ed essere liberato dalle vecchie norme; deve oltrepassare da sé e procedere verso il proprio destino: quello del superuomo, dell'oltre-uomo.
Già Schopenhauer aveva affermato che la vita è cieca irrazionalità, priva di senso e di qualsiasi fine, e che pertanto unica soluzione per l'uomo era il distacco dalle cose e dalle passioni, la rinuncia e la fuga dal mondo, ossia l'ascesi. Nietzsche condivide questa concezione ma non la conclusione ascetica: la vita non deve essere rifiutata ma, contro tutti i modelli imposti dalla morale borghese e cristiana, va amata e vissuta nella sua immediatezza, anche nei suoi aspetti irrazionali, più tragici e crudeli.
Spirito dionisiaco e spirito apollineo:
le origini della cultura e la critica di quella contemporanea.
Nietzsche è insoddisfatto della cultura del suo tempo che giudica falsa ed illusoria.
Compie perciò un'analisi della storia della cultura, fin dalle sue origini, per comprendere come è nata e come si è via via deformata e corrotta nel tempo. Punto di partenza è l'analisi della cultura greca e, in particolare, l'analisi della nascita della tragedia greca antica quale principale forma d'arte dell'epoca. La tragedia greca più antica non nasce nel periodo classico della civiltà greca, quello della civiltà ateniese e della filosofia socratica e platonica, ma sorge prima, nel periodo presocratico del VI secolo a. C. Nietzsche ammira l'atteggiamento che i greci dell'età presocratica avevano nei confronti della vita. Sapevano che la vita è gioia ma anche dolore e tormento. Soprattutto sapevano che la vita non ha alcun senso, alcuna giustificazione razionale o teologico-religiosa, pensata anzi come incessante svolgimento di vicende dominate da un destino cieco e crudele che, come in Schopenhauer, non ha altro scopo se non la realizzazione e l'accrescimento della sua potenza. Eppure, constata Nietzsche, i greci di quel tempo vivevano pienamente la loro esistenza, nel modo soprattutto espresso dalla tragedia. In essa è ravvisata la rappresentazione di tutte e due le peculiarità che contraddistinguono la vita e la cultura, chiamate, rispettivamente, "spirito dionisiaco" e "spirito apollineo".
Lo spirito dionisiaco (dal dio greco Dioniso, Bacco) è quello che deriva dagli istinti irrazionali, dalle passioni sfrenate, dalle forze oscure della vita, quali espressi nei riti orgiastici, nelle danze passionali, nei miti terribili che parlano di morte e distruzione, di maledizione e persecuzione, e che ha la sua massima esaltazione nella musica, ritenuta l'arte più capace di suscitare passioni. Lo spirito apollineo (dal dio delle arti Apollo) deriva invece da un sentimento di serenità e di armonia provato nei confronti della vita ed ha nella scultura e nella poesia le sue maggiori espressioni.
Entrambi questi spiriti, fra di essi contrapposti, sono rappresentati nella tragedia greca di Eschilo e Sofocle. Anzi, lo spirito dionisiaco assume maggior rilievo avendo la tragedia antica come elemento fondamentale il coro, composto dai seguaci di Dioniso mascherati da capri. Lo stesso eroe tragico, il protagonista, è una maschera, una raffigurazione del dio Dioniso e concomitante è il senso di accettazione ebbra della vita, di esaltazione degli istinti e del coraggio di fronte a un fato crudele. La contrapposizione tra spirito dionisiaco e spirito apollineo presente all'origine della tragedia greca viene però meno, rileva Nietzsche, col sorgere della filosofia socratica e platonica, che comporta il prevalere dello spirito apollineo, ossia di una concezione idealizzata della vita e della cultura fatta essenzialmente di ordine e di equilibrio, mentre lo spirito dionisiaco viene svalutato. Socrate pretende di capire e di controllare la vita con la ragione e con la morale, nell'illusione che la vita e il mondo siano razionali e quindi spiegabili. Platone, col suo mondo delle idee, ci presenta addirittura l'esistenza di un mondo sovrannaturale rispetto al mondo terreno. Ma quella di Socrate e di Platone è vista come una rinuncia alla vita vera, che è quella degli istinti. Con loro comincia la decadenza della cultura e la morte dello spirito dionisiaco. Nella contrapposizione tra istinto e ragione si è voluto far prevalere quest'ultima, sennonché questa è una raffigurazione idealizzata, non veritiera, della vita e della cultura. Sicché Euripide, il terzo noto tragediografo greco, trasferisce nel teatro le nuove e idealizzate concezioni moralistiche. Il protagonista delle sue tragedie, ormai annacquate e svigorite, non è più l'eroe tragico e tormentato ma l'uomo comune, mediocre ed ingenuo, il quale si illude di trovare la verità in una morale meschina, supposta in grado di distinguere il bene dal male, incapace di comprendere che l'esistenza è invece piena di contraddizioni.
Francesco Lorenzoni,
25 luglio 2018
Francesco Lorenzoni
L'uomo è chiamato da Heidegger “esserci”, ove il “ci” sta ad indicare che l'uomo, secondo la prospettiva esistenziale, è sempre in una situazione in cui, con la nascita, si trova involontariamente gettato ad esistere dal nulla giacché fonte ignota, inesplicabile.
SIGMUND FREUD (1856-1939) 1
Nasce a Freiberg in Moravia. Si laurea in medicina a Vienna; compie studi di neurologia e successivamente si dedica alla psichiatria. Si reca a Parigi con una borsa di studio e si applica a studi sull'isteria. Tornato a Vienna, giunge alla scoperta dell'inconscio e alla fondazione della psicoanalisi, concepita come metodo scientifico per l'analisi dei processi psichici inconsci.
Come tale, la psicanalisi è rivolta soprattutto alla cura delle malattie mentali, ma offre anche molti spunti per la comprensione più in generale del comportamento umano. Ha avuto perciò rilevante influenza sulle scienze umane, antropologia e sociologia in particolare, nonché sull’arte, sulla letteratura e sulla filosofia. Perseguitato dai nazisti in quanto ebreo, Freud ripara Londra nel 1938 come esule, dove muore.
Opere principali:
L'interpretazione dei sogni; Tre saggi sulla teoria sessuale; Al di là del principio del piacere; Il disagio della civiltà; Totem e tabù.
La scoperta dell'inconscio.
La scoperta dell'inconscio è la novità più importante della psicoanalisi, cui Freud giunge in seguito agli studi sull'isteria. Prima di Freud le malattie mentali, secondo la concezione positivistico-materialistica divenuta prevalente, erano considerate alterazioni del sistema nervoso di tipo organico, dovute a lesioni del cervello, e non venivano presi in considerazione stati psiconevrotici in cui tali lesioni non fossero invece rintracciabili. Freud elabora una diversa interpretazione dei disturbi mentali. Gli studi sull'isteria avevano infatti mostrato che la guarigione del paziente era possibile facendo riemergere alla coscienza episodi sgradevoli dell'infanzia dimenticati a livello cosciente, venendo così a scoprirsi l’esistenza di disturbi mentali che non hanno niente di organico. Ciò induce Freud a mettere in luce un fatto fondamentale, ossia che al di sotto della coscienza esiste un mondo di desideri, di fantasie, di istinti e di impulsi, ovvero l'inconscio, di cui il soggetto non è consapevole ma che è causa di numerose nostre azioni e condiziona tutta la nostra vita psichica.
Per poter conoscere l'uomo bisogna quindi esplorare l'inconscio, questa zona oscura, questo agglomerato di pulsioni. Al riguardo Freud ricorre dapprima al metodo dell'ipnosi che poi, perché insoddisfacente, abbandona per adottare invece il metodo delle associazioni libere: facendo parlare liberamente il paziente colpito da patologia mentale, capita che le sue idee, pensieri e parole si associno e si sviluppino secondo criteri apparentemente illogici, che possono però rivelare gli stati d'animo e le tensioni profonde dell'inconscio. Cogliendo ed interpretando i lapsus, i blocchi improvvisi, le esitazioni, diviene possibile per il medico far emergere il contenuto dell'inconscio bloccato dalla coscienza e condurre il paziente alla guarigione. Si afferma in tal modo la tesi per cui in molti casi la causa dei disturbi nervosi, in specie le isterie, non è da ritenersi di natura fisiologica ed organica ma psichica, determinata dalle tensioni esistenti all'interno dell'inconscio tra pulsioni sepolte nel profondo, avvertite in contrasto con la coscienza e per le quali a livello cosciente si prova vergogna.
Poiché l'inconscio agisce non solo sui soggetti malati ma è presente in tutti gli uomini e ne influenza i comportamenti, dalla scoperta della forza condizionante dell'inconscio è derivata una nuova e rivoluzionaria visione della natura umana. Ne è risultata sconvolta la tradizionale concezione di coscienza intesa come lucida espressione della razionalità. La cognizione che la maggior parte della vita mentale si svolge al di fuori della coscienza, e che il conscio è solo la manifestazione consapevole e visibile della psiche di cui, anzi, occupa solo la superficie, ha marcato l’intera cultura.
I fattori della vita psichica e la struttura della personalità
In una prima sistemazione teorica della sua dottrina, chiamata la prima topica ad indicare i luoghi della psiche, Freud individua tre fattori operanti nella vita psichica dell'uomo:
1. il conscio, ovvero tutto ciò di cui siamo consapevoli;
2. il preconscio, ovvero tutto ciò che non è presente a livello cosciente ma che può essere facilmente richiamato alla coscienza;
3. l'inconscio, ovvero tutto ciò che è nel profondo della psiche umana su cui nulla può la coscienza.
Più importante è la sua seconda sistemazione teorica, la seconda topica, in cui Freud distingue tre diverse componenti della psiche o, meglio, della struttura della personalità:
1. l'Es, cioè l'inconscio, ossia il "calderone degli istinti ribollenti", la forza caotica che costituisce la materia originaria della psiche, la quale non conosce né il bene né il male né la morale, ma ubbidisce unicamente al principio del piacere ignorando le leggi della logica; è un coacervo di impulsi contraddittori;
2. il Super-io o Super-ego, che è ciò che comunemente è chiamato "coscienza morale", ossia l'insieme delle norme, dei valori, dei simboli, dei divieti e delle proibizioni, interiorizzati e appresi dall'individuo fin dai primi anni di vita attraverso l'educazione ed il suo inserimento nella società; il Super-io è quindi un censore severo che punisce, sviluppando un senso di colpa, ogni trasgressione, ogni desiderio che sia in contrasto con i valori, i costumi e le consuetudini della società;
3. l'Io, o l'Ego, che rappresenta il livello conscio, che però non perviene a consapevolezza piena poiché condizionato dalle sollecitazioni e tensioni che provengono, oltre che dal mondo esterno, sia dal inconscio sia dal Super-io; l'Io si trova in mezzo a queste spinte antitetiche, le tentazioni dell'Es da una parte e i richiami del Super-io dall'altra, contrasti che si trova quindi a dover mediare, ad equilibrare, mediante opportuni compromessi.
Nell'individuo normale l'Io riesce abbastanza bene a controllare la situazione. Agendo secondo il principio della realtà (il buon senso), concede parziali soddisfazioni all'Es senza violare in forma vistosa i precetti del Super-io. Ma se l'Es è troppo forte o il Super-io è troppo debole o troppo rigoroso, l'Io non riesce ad equilibrare le spinte contrastanti. La sua impotenza produce angoscia e l’Io è condotto a comportamenti asociali, delinquenziali o perversi. Quando invece il Super-io è troppo rigido, esso provoca la rimozione, la soppressione forzata delle pulsioni e dei desideri dell'Es, e possono allora derivare stati di nevrosi e di psicosi.
Rispetto alla rimozione degli istinti, che più di talvolta può provocare danni collaterali, un meccanismo più equilibrato di difesa nei confronti dell'Es è quello della "sublimazione", verso cui il terapeuta tende a indirizzare, mediante cui l'Io trasferisce gli istinti dell'Es verso méte ed obiettivi socialmente accettabili, quali ad esempio l'impegno e la gratificazione nel lavoro, nell'arte, negli ideali.
Le nevrosi e psicosi possono guarire quando il malato prende coscienza, mediante la psicoanalisi, del conflitto che subisce e lo supera anche attraverso il delicatissimo rapporto detto "transfert", ossia il trasferimento sulla persona del medico di stati d'animo ambivalenti e contrapposti di amore e odio, provati dal paziente durante l'infanzia nei confronti dei genitori.
Francesco Lorenzoni,
9 agosto 2018
Andrea Ventimiglia
Intervengo segnalando che quanto scritto, oltre che essere un'estrema sintesi più o meno apprezzabile, presenta un errore tecnico quale quello relativo al tema della guarigione.
In particolar modo, in relazione alle psicosi, freud non menziona alcun tipo di guarigione. È una critica che viene mossa a Freud stesso il fatto di non proporre, diciamo così, alcun tipo di possibile guarigione al soggetto psicotico.
Secondo la psicoanalisi del tempo le psicosi erano inaccessibili al metodo.
Si può ritrovare in "Nevrosi e Psicosi" e in "La perdita di realtà nella nevrosi e nella psicosi" un' importante paragone tra le due strutture al fine di comprendere ancor più approfonditamente il funzionamento delle istanze dell'apparato psichico umano.
Marcus Holder
Grazie! Sintesi più che apprezzabile, non dovendo essere questo un post da...esame universitario.
Riguardo alla "guarigione" delle psicosi, sicuramente non si può parlare di guarigione.
Almeno non nel senso che possiamo usare ad esempio nelle nevrosi.
Nelle psicosi vi è una frattura dell'Io più o meno marcata, ma pur sempre una frattura.
E a tutt'oggi non esiste "cura" che possa riportarlo alla sua integrità.
Fortunatamente i farmaci (antipsicotici) riescono - insieme, ma ben più della parola! - a rendere la vita di queste persone e soprattutto dei loro cari più vivibile.
Francesco Lorenzoni
Grazie delle precisazioni che accolgo molto volentieri. Ho parlato di guarigione in termini ordinari e, riconosco, non appropriati.
JOHN LOCKE (1632 – 1704) 2
La critica alla sostanza
Quando si vede un oggetto si percepiscono solo le sue qualità primarie e secondarie, che sono idee semplici; non ne vediamo la sostanza ma soltanto la forma, la figura, la grandezza, il colore, il sapore, se è solido o liquido, e così via. La sostanza, prende posizione Locke, non è entità reale bensì un’idea complessa generata dalla mente e che deriva dall'abitudine, dalla ripetizione di percezioni costanti. Quando osserviamo che un certo numero di idee semplici, o qualità, sono costantemente unite tra di loro, la mente, abituandosi a vederle sempre insieme, comincia a ritenere che quelle idee o qualità, provocate dall’oggetto, non costituiscano un’idea complessa ma che compongano nel loro insieme, in contraddizione con la sua indivisibilità, un'unica idea semplice, ovvero un’unica base comune su cui si appoggiano e che chiamiamo sostrato o sostanza. Se vede sempre unite fra loro qualità o idee semplici di sensazione, la nostra mente suppone che al di sotto di esse vi sia una sostanza corporea; se vede invece sempre unite fra loro qualità o idee semplici di riflessione, la nostra mente suppone che al di sotto di esse vi sia una sostanza spirituale. Locke invero non nega che, al limite, possa sussistere una sostanza al di sotto delle qualità primarie e secondarie percepite, ma nega che noi possiamo conoscerla poiché, come idea complessa costruita dall’intelletto, nella realtà esterna essa è inesistente, comunque oggettivamente inconoscibile e, quantomeno, assai dubbia come realtà in sé. Si tratta di un giudizio cruciale: con la critica dell'idea di sostanza è messo in dubbio uno dei fondamenti della metafisica, sia tradizionale sia moderna, che proprio sulla conoscibilità della sostanza fonda molte delle sue teorie.
Le forme del conoscere
L'esperienza, quale punto di partenza della conoscenza, fornisce il materiale della conoscenza ma non è ancora la conoscenza. La conoscenza riguarda sempre le idee ma la sua peculiarità consiste nel percepire l'accordo o il disaccordo tra le idee ricevute dall'esperienza. Tipi di accordo-disaccordo tra le idee sono l’identità e la diversità, la relazione, la connessione necessaria o contingente, l'esistenza reale o immaginaria.
L'accordo o disaccordo tra le idee può essere percepito in due modi diversi, per cui vi sono due specie di conoscenza:
1) la conoscenza intuitiva, quando l'accordo o disaccordo fra due o più idee è percepito immediatamente, in un colpo solo, senza che l'intelletto senta l'esigenza di prove e dimostrazione (ad esempio il bianco non è nero; tre è più di due, ecc.);
2) la conoscenza dimostrativa, quando l'accordo o disaccordo tra due o più idee non viene percepito immediatamente ma gradualmente attraverso il ragionamento, scomponendo le idee nelle loro parti e individuando le idee intermedie (chiamate prove) che collegano le varie parti. Ad esempio, l'idea di "uomo" e l'idea di "mortale" sono in accordo o no? Scompongo l'idea di uomo e vedo che è un essere naturale animato; scompongo l'idea di mortale e vedo che tutti gli esseri naturali animati muoiono; perciò si può concludere che l'idea di uomo e l'idea di mortale sono in accordo. La conoscenza dimostrativa può comportare una serie di ragionamenti e di scomposizioni molto lunghe, per cui è possibile sbagliare. Consegue che la conoscenza dimostrativa è meno sicura di quella intuitiva.
Nel campo della teoria della conoscenza vi è inoltre, stante la natura fenomenica del nostro conoscere, quell’altro decisivo problema concernente la possibile conoscenza effettiva delle cose esistenti al di fuori della mente. Cartesio aveva risolto questo problema con la prova dell'esistenza di Dio: dimostrando che Dio esiste e che è buono, e quindi non può ingannarci, egli allora ci garantisce che le nostre sensazioni e facoltà conoscitive, che Dio stesso ci ha donato, corrispondono davvero alle cose esterne. Ma Locke, da filosofo empirista, risolve il problema in un altro modo. Egli osserva che ci sono tre tipi di realtà e che ci sono tre modi diversi per giungerne alla conoscenza:
1. c'è la realtà dell’"io", della nostra coscienza, di cui abbiamo una conoscenza intuitiva, a cui si giunge in maniera simile a quanto asserito da Cartesio: io penso, quindi sono, ossia intuisco l'esistenza del mio "io" come fatto indubitabile, tenuto tuttavia presente che per Locke si ha coscienza intuitiva dell'io non già perché sia una sostanza, avendo negato, si è visto, l’esistenza delle sostanze, ma perché permane nell'io la memoria individuale delle esperienze, dei pensieri e dei sentimento provati;
2. c'è la realtà di Dio, del quale per Locke, analogamente alle dimostrazioni aristoteliche, abbiamo una conoscenza dimostrativa, in particolare quella attinente la prova causale: poiché nulla nasce dal nulla e poiché non si può risalire all'infinito nella ricerca della causa, si deve allora ammettere che esiste un essere eterno e onnipotente che ha prodotto e creato ogni cosa: questo essere è Dio;
3. c'è la realtà delle cose esterne, di cui abbiamo una conoscenza per sensazione. E’ vero, dice Locke, che noi non conosciamo direttamente le cose esterne ma solo le idee, le loro immagini fenomeniche, però, se riceviamo queste idee dall'esterno, vuol dire che al di fuori della nostra mente ci deve essere qualcosa, una realtà, che le trasmette a noi. Dunque le cose esterne esistono, tant'è vero che il nostro intelletto riceve le idee delle cose esterne senza poterlo evitare, anche se non lo volesse. Perciò non possono essere create dall'intelletto stesso. Nel momento in cui riceviamo una sensazione possiamo essere certi che fuori di noi esiste un oggetto che in noi la produce; e questa certezza è sufficiente a garantire la realtà delle cose esterne. Da empirista coerente Locke ripone fiducia nelle nostre facoltà sensitive. Non ritiene possibile che i sensi ci ingannino al punto di smentire questa nostra convinzione.
Sennonché, ravvisa Locke, la sensazione circa l'esistenza di cose esterne, causa delle nostre idee, è certa solo quando la sensazione è attuale. Quando invece una sensazione non è attuale, perché non viene più ricevuta o perché riguarda una previsione futura, allora la nostra conoscenza sensibile non è certa ma solo probabile. Comunque è bastevole per gli scopi pratici della vita; è cioè ragionevole pensare che cose e uomini continuino ad esistere anche quando non se ne ha percezione attuale. Singolare è la derivante conclusione: dell'esistenza delle cose sensibili non attuali siamo meno certi dell'esistenza di Dio, del quale abbiamo, viceversa, conoscenza per dimostrazione.
JOHN LOCKE (1632 – 1704) 3
L’etica e la politica
Dopo le indagini sull'intelletto, Locke si dedica ai problemi che più gli stanno a cuore, ossia quelli etici e politici, esposti nell'opera "Due trattati sul governo".
L'etica di Locke ha un carattere utilitaristico. Non si ispira all'idea del bene in sé, del bene in assoluto, poiché è un'idea astratta, prodotta dall’intelletto ed inesistente nella realtà, quindi non percepibile, non conoscibile, ma si ispira al criterio dell’utilità: la morale consiste in comportamenti che siano utili a noi e alla società. Ed è la ragione che stabilisce e giudica quali sono i comportamenti e le azioni utili. Discende che la morale non deriva dalla religione, dalla quale è autonoma.
Nel contesto della morale, la libertà non è da Locke concepita come "libero arbitrio" poiché trattasi di concetto implicante considerazioni metafisiche sul bene e sul male in sé, estranee al suo empirismo. Di conseguenza, la libertà non sta nel "volere" ma nel poter agire o astenersi dall'azione o anche nel tenerla in sospeso.
In politica Locke respinge, in primo luogo, la teoria medievale dell'origine divina della sovranità. La sovranità è di origine umana e deriva dal popolo.
Circa l'origine dello Stato, è rifiutata la concezione di Hobbes secondo cui la condizione di natura originaria degli uomini è quella dell'egoismo, della prepotenza e della guerra di tutti contro tutti. Nello stato originario di natura, per Locke, gli uomini si sentono invece tutti uguali, tutti sanno riconoscere che ciascuno possiede irrinunciabili diritti naturali alla vita, alla libertà e alla proprietà dei frutti del proprio lavoro. Tuttavia, poiché vi può sempre essere qualche prepotente che non rispetta tali diritti, gli uomini si mettono allora d'accordo e stipulano un patto sociale per creare uno Stato, ma non per cedere al sovrano, rinunciandovi, ogni diritto, fatta solo eccezione per il diritto alla vita, bensì per affidarvi invece la difesa di tutti i diritti naturali, che individualmente ognuno seguita a conservare. Formando uno Stato, gli uomini rinunciano solo al diritto di farsi giustizia da sé, però soltanto per difendere e garantire meglio tutti gli altri diritti. Consegue che, diversamente da Hobbes, il patto o contratto sociale da cui nasce lo Stato non è tra i sudditi fra loro ma tra i cittadini e il sovrano, che pertanto non è più al di sopra della legge e delle regole del patto, anch'egli tenuto ad osservarle. Il sovrano rimane sottoposto al giudizio dei cittadini, che mantengono la facoltà di ribellarsi se il sovrano non ne rispetta i naturali diritti.
Lo Stato non è più quello assoluto di Hobbes. Locke è, invece, il difensore dello Stato costituzionale e del liberalismo politico. I limiti del potere dello Stato sono stabiliti dalla costituzione e dal principio della divisione dei poteri tra potere legislativo, potere esecutivo e potere giudiziario.
Tolleranza e religione
L'opera di Locke "Epistola sulla tolleranza" è uno degli scritti più celebri sulla libertà di coscienza religiosa, valido ancora oggi. Giunge al concetto di tolleranza religiosa confrontando tra essi lo Stato e la Chiesa. Lo Stato è un prodotto umano per garantire i beni civili, ossia i diritti naturali di ogni uomo, che diventano beni civili quando la loro difesa è affidata allo Stato. Questo è il compito dello Stato e non altro. La salvezza dell'anima è chiaramente al di fuori di tale compito. L'unico strumento che lo Stato possiede per difendere i diritti dei cittadini è la costrizione, la forza della legge e della condanna penale nei confronti di coloro che non rispettano le norme stabilite. Ma l'imposizione con la forza non può condurre alla salvezza dell'anima perché nessuno può essere salvato per forza se non lo vuole e non ne è persuaso. La salvezza dell'anima dipende dalla fede e la fede non può essere imposta. La Chiesa o anche i cittadini non possono chiedere l'intervento e la forza della legge per costringere a credere in una religione. La Chiesa, asserisce Locke, è una libera associazione di uomini che si riuniscono spontaneamente per venerare Dio. Come associazione libera e volontaria la Chiesa non può usare la forza della legge e delle pene perché esse sono riservate allo Stato. Del resto, anche se la Chiesa usasse la forza per costringere a credere, gli esiti sarebbero inutili e dannosi poiché nessuno può essere forzato ad aver fede. Certo, la Chiesa ha il diritto di scomunicare coloro che non osservano più i suoi precetti. Ma in ogni caso gli scomunicati non possono perdere i loro diritti civili e la loro cittadinanza.
Svolgendo compiti diversi, che però non entrano in contrasto fra essi, Stato e Chiesa sono autonomi: lo Stato non deve intervenire nelle questioni religiose e di fede e la Chiesa non deve intervenire nelle questioni politiche e civili. E ciò vale per qualsiasi Chiesa. Perciò deve esserci tolleranza per qualunque religione, giustificandosi l’intolleranza soltanto contro gli intolleranti. La religione non deve essere dogmatica e fanatica. Essa si basa sulla rivelazione divina e non sulla ragione, ma non deve essere irragionevole, assurda e in contrasto con la ragione. In tal senso, Locke ritiene il cristianesimo protestante la più ragionevole tra le varie religioni, mentre critica il cattolicesimo e il papato poiché, a causa del rivendicato potere temporale, la Chiesa cattolica non si occupa solamente della cura delle anime, in conflitto col principio dell’autonomia tra religione e politica.
Francesco Lorenzoni, 20 dicembre 2017
Considerazioni:
Giuseppe Arena:
non bisogna mai dimenticare, per capire il pensiero di un filosofo, il contesto storico e temporale in cui egli vive. Locke vive in un momento nel quale si scatenano sanguinose guerre fra uomini di fede religiosa e di idee politiche differenti,per cui le opere del filosofo (vedi Lettera sulla tolleranza) sono segnate dalla volontà di fondare come valore universale la tolleranza. Locke considera la fede religiosa come una scelta libera e privata di ogni uomo che nessuna autorità esterna può imporre. Dannosa, pertanto, allo stato é ogni forma di persecuzione, perché essa non fa altro che produrre una coalizione di dissidenti e trasformare il dissenso religioso in opposizione politica. Ed a proposito di tolleranza ed ad avvalorare la mia tesi, secondo la quale é importante considerare il periodo storico in cui vive il filosofo e la sua vita,per capirne il pensiero, vorrei ricordare che anche Voltaire, in merito alla tolleranza,scrisse il "Trattato sulla tolleranza". Il periodo storico era pressapoco lo stesso (1600- 1700) e molto importante, nello sviluppo di questa posizione del pensiero di Voltaire, fu il suo soggiorno in Inghilterra, compiuto tra il 1726 e il 1729, ed il suo incontro col pensiero di Locke.
DAVID HUME (1711 – 1776) 1
Nasce a Edimburgo in Scozia. È stato bibliotecario presso la locale università nonché precettore e segretario di personaggi militari e politici.
Opera principale: Trattato sulla natura umana.
È l'ultimo, in ordine di tempo, dei grandi filosofi empiristi del Seicento-Settecento.
Sviluppa ed approfondisce le teorie filosofico-empiristiche di Locke, di cui mostra anche quelli che, a suo avviso, sono i problemi e i limiti.
Interesse prevalente di Hume è lo studio della natura umana, comprendere com’è veramente fatto l'uomo per quanto riguarda sia la conoscenza sia anche i sentimenti, la morale, la società. Intende praticarne lo studio in modo scientifico, applicando il metodo scientifico-sperimentale di Newton. A tale studio attribuisce valore preliminare perché da esso, asserisce, dipendono anche i progressi di tutte le altre scienze. Le scienze, afferma, non sono neutrali; il loro sviluppo è condizionato dal modo di pensare, di conoscere, di sentire e di credere degli uomini. La filosofia perciò non deve essere solo dei filosofi ma di tutti; deve occuparsi anche della vita comune e deve usare un linguaggio meno specialistico, più semplice e comprensibile.
Per quanto siano di interesse anche le concezioni circa la morale, la società, la politica e la religione, l'importanza di Hume nella storia della filosofia sta soprattutto nella sua teoria della conoscenza, particolarmente nella sua critica del principio di causalità.
La conoscenza
Nel solco dell’empirismo, anche Hume afferma che i contenuti della mente sono solo quelli che essa riceve dall'esperienza esterna o interna.
Due ne sono, precisamente, i contenuti:
1. le impressioni, ossia le percezioni attuali (le sensazioni, le passioni, le emozioni) , le quali raggiungono la mente con maggior forza ed intensità;
2. le idee, che sono immagini indebolite delle impressioni allorquando esse, costituite dai ricordi, dalla memoria, non sono più attuali.
L’intelletto dapprima riceve le impressioni e poi, quando diventano un ricordo, le trasforma in idee. Le idee sono pertanto un derivato dalle impressioni. Al di fuori delle impressioni e delle idee l’intelletto non contiene niente altro: non ci sono idee innate né concetti universali, i quali sono solo nomi astratti collettivi (nominalismo).
Locke aveva riconosciuto, al di là delle idee, l'esistenza di realtà esterne (la realtà dell’"io", di Dio, delle cose naturali), ammettendo da un lato la possibilità di conoscerle mediante l'intuizione o la dimostrazione oppure attraverso la sensazione attuale, e non ammettendo, dall’altro, il regresso all’infinito lungo la catena della causalità. Hume è più radicale: anche se vi fossero, tali realtà sono comunque inconoscibili; noi conosciamo unicamente le nostre impressioni e idee. Non siamo altro, dice, che "un fascio di impressioni e di idee" e non siamo assolutamente in grado di sapere se al di fuori vi siano corrispondenti realtà qualificabili come causa delle nostre impressioni e idee.
Essendo la realtà esterna inconoscibile, l'intelletto non funziona stabilendo connessioni tra idee della mente e cose esterne, ma stabilendo invece connessioni tra le idee fra di esse. Tale facoltà è chiamata da Hume immaginazione. L'immaginazione non associa le idee a caso, ma realizza l'associazione di un'idea ad un'altra secondo tre criteri:
1. per somiglianza;
2. per contiguità nello spazio o nel tempo;
3. per relazione di causa-effetto.
L'associazione tra due o più idee produce le idee complesse, analoghe a quelle di Locke, ossia produce concetti astratti, di cui i più importanti sono le idee di spazio, di tempo e di causalità che noi, sbagliando, siamo abituati a pensare come realtà esteriori oggettive, mentre sono soltanto combinazioni di idee. Hume distingue tra:
1. relazioni fra idee, che sono quelle proposizioni ricavate non dall'esperienza ma da principi logico-matematici (identità, non contraddizione, ecc.) e che Kant chiamerà “giudizi analitici a priori”; essendo basate sulla logica, e non sull'esperienza, le relazioni tra idee sono sempre valide e necessarie ma non aumentano la nostra conoscenza perché il predicato è implicito nel soggetto;
2. dati di fatto, che sono quelle proposizioni (ad esempio, domani pioverà o non pioverà) il cui contrario è sempre possibile in quanto non sono fondate sulla logica ma sull'esperienza, che può essere di un tipo o del tipo contrario; i dati di fatto, che Kant chiamerà “giudizi sintetici a posteriori”, aumentano la nostra conoscenza (il predicato aggiunge qualcosa di nuovo al soggetto della proposizione, come quando si dice “questo quadro è bello o è brutto”), però non garantiscono una conoscenza certa sia perché non si può fare esperienza di tutto sia anche perché, in futuro, le cose potrebbero andare diversamente da come la passata esperienza le ha mostrate.
La distinzione tra relazioni fra idee e dati di fatto, le prime basate sul principio di non contraddizione e i secondi su quello di causalità, dedotto dall'esperienza di una ripetuta associazione di idee, è analoga a quella di Leibniz tra verità di ragione verità di fatto, sennonché Hume valuta la legge di causalità e, a maggior motivo, il leibniziano principio di ragion sufficiente niente affatto evidenti e validi in assoluto.
Francesco Lorenzoni, 27 dicembre 2017
DAVID HUME (1711 – 1776) 2
Critica alle idee di spazio, di tempo, di causalità, di mondo, di sostanza materiale e spirituale
Da risoluto empirista, Hume procede, in modo estremo, a criticare come inconsistenti le varie idee metafisiche di spazio, di tempo, di causalità, di mondo, di sostanza materiale e di sostanza spirituale, sostenute invece dalla filosofia razionalistica.
In quanto trattasi solo di idee complesse, non di entità ma di associazione di idee, lo spazio e il tempo, egli afferma contrariamente a quanto pensava Newton, non esistono nella realtà; sono semplicemente nostri modi di misurare, di pensare e di vedere, frutto della nostra immaginazione: quando abbiamo l'impressione di due o più idee l'una accanto all'altra siamo portati a pensare che esse stiano in un certo spazio; quando abbiamo l'impressione di due o più idee l'una dopo l'altra pensiamo che si succedano tra di esse in un certo tempo.
Anche la causalità, ovvero la relazione di causa-effetto, è per Hume un'idea complessa frutto dell’immaginazione, la quale suppone l'esistenza di un rapporto costante tra un certo effetto e una predeterminata causa. Ma, asserisce, non vi è connessione necessaria tra causa ed effetto tale per cui, data una certa causa, consegua sempre quel certo effetto per necessità logica. Non è contraddittorio supporre che da una medesima causa derivino effetti differenti o nessun effetto. Nessuna analisi della causa può farci scoprire a priori l'effetto necessariamente e costantemente derivante. Il fatto di aver sempre constatato, per esperienza, che il Sole illumina la Terra, considerato perciò quale causa della diffusione della luce, non autorizza a concludere con assoluta certezza logica che sarà sempre così anche in futuro, magari in un tempo lontano. L'immaginazione di un rapporto necessario di causa-effetto deriva viceversa dall'abitudine. Poiché sono abituato a vedere che, col sorgere del Sole, la Terra si illumina, sono portato a supporre che il Sole sia e sarà causa necessaria e permanente della luce sulla Terra e che, viceversa, la luce sulla Terra sia e sarà sempre perdurante effetto necessario del sorgere del Sole. Ma questa non è una verità logica, universale e necessaria, è semplicemente una nostra credenza, una semplice aspettativa derivante da una abitudine acquisita. Non vi è alcuna dimostrazione scientifica della verità del principio di causalità. Tale principio, su cui finora si è sempre fondata la conoscenza e la scienza (secondo la concezione che conoscere una cosa vuol dire scoprirne la causa) non ha pertanto valore scientifico. Tuttavia, ammette Hume, l'abitudine non va disprezzata perché è comunque una guida valida per la vita pratica, pur non costituendo principio certo di spiegazione razionale.
Non solo, ma poiché l'intelletto è fatto unicamente di impressioni e di idee, presenti solo nella mente, non può nemmeno esserci conoscenza diretta delle cose esterne, che Hume chiama sostanze materiali. Anzi, addirittura non siamo nemmeno sicuri se le cose esterne esistano. Porre in dubbio l'esistenza delle cose esterne significa dubitare dell'esistenza stessa della materia e, quindi, mettere in dubbio l'esistenza dell'intero mondo fisico. Tutto dipende dalla possibilità di dimostrare se le sostanze materiali, o sostrati, su cui si appoggerebbero le qualità primarie e secondarie delle cose percepite, esistono o no al di fuori della nostra mente. Ma pensare che le sostanze materiali esistano al di fuori di noi non è affatto conoscenza sicura. Anche tale pensiero, come l’idea del principio di causa, è piuttosto una credenza soggettiva poiché non è possibile vedere e sperimentare la sostanza interna delle cose, di cui non è dato dimostrare scientificamente, oggettivamente, la sussistenza. Ad esempio, noi non facciamo esperienza e non vediamo la sostanza o sostrato della penna con cui scriviamo; percepiamo solo impressioni di un cilindro in grado di scrivere, liscio, sottile, colorato, ecc. Considerare che al di sotto di tali impressioni vi sia una sostanza, un sostrato che le sorregga, è mera induzione soggettiva. Chiamiamo "penna" questa sostanza, che rimane tuttavia invisibile, quindi non sperimentabile e non dimostrabile.
Va messa in dubbio pure la stessa idea di esistenza di quella sostanza spirituale che chiamiamo coscienza o "io" o anima, intesa come sostrato su cui poggiano tutte le nostre impressioni, le nostre idee, i nostri pensieri. Neppure del nostro "io", della nostra coscienza, abbiamo conoscenza ed esperienza diretta. Perciò non è possibile dimostrarne l'esistenza dal momento che abbiamo esperienza interna soltanto dei singoli successivi stati d'animo (gioia, dolore, piacere, tristezza, specifiche riflessioni, ecc.) ma non già dell’intera coscienza. Anche l'idea di coscienza è pertanto una semplice credenza e frutto dell'abitudine: poiché siamo abituati a riferire certe impressioni a noi stessi anziché ad un corpo esterno, finiamo col credere di essere un soggetto distinto dalle nostre impressioni.
Hume perviene in tal maniera ad esiti di esplicito scetticismo ontologico e gnoseologico. Meno scettico è invece sul piano pratico, in quanto giudica le nostre credenze ed abitudini sufficienti in ogni caso a guidare e regolare la vita quotidiana. Ciò significa che Hume, in fondo, non nega in modo reciso l’esistenza della realtà esterna quanto invece la sua conoscibilità certa. In definitiva, la natura umana è per Hume più istinto pratico che ragione. La pratica vale di più della teoria e le abitudini costituiscono l’esclusiva spiegazione del pensare e dell’agire umano. Stante sul piano teoretico questa radicale sfiducia nella conoscenza, la risposta al problema di come indirizzare la vita è fornita sul piano pratico dalla teoria humiana della credenza: è la credenza che indirizza l’uomo nelle sue azioni, che lo spinge a credere, anche se non lo sa con certezza, che il fuoco porta calore, che le nuvole promettono pioggia, che domani nascerà ancora il sole.
Giuseppe Arena
A me pare che Hume, invece di affrontare il problema della conoscenza, sia in maniera ontologica che gnoseologica, e dare una spiegazione al perché delle cose, si tenga, come suol dirsi, "alla larga.
A differenza dei razionalisti che hanno affrontato il problema, pervenendo ad esiti diversi, anche se personali e discutibili, relegando tutto alle abitudini, eliminando il nesso causa-effetto, Hume non fa altro, a mio avviso, che riportare il tutto alla soggettività, eliminando ogni barlume di conoscenza razionale.
Francesco Lorenzoni, 30 dicembre 2017