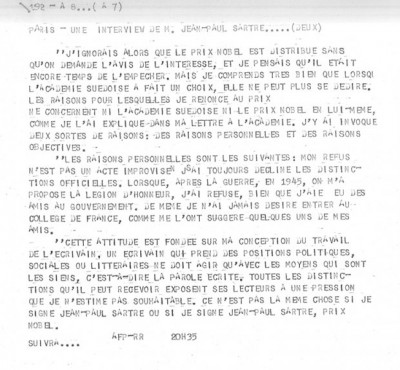David Foster Wallace
La vostra preoccupazione per ciò che gli altri pensano di voi scompare una volta che capite quanto di rado pensano a voi .
David Foster Wallace
Come è che David Foster Wallace iniziava il suo racconto più struggente,
“Caro vecchio neon”, in Oblio?
Per tutta la vita sono stato un impostore. E non esagero.
Ho praticamente passato tutto il mio tempo a creare un’immagine di me da offrire agli altri, più che altro per piacere o per essere ammirato. Forse è un po’ più complicato di così. Ma se andiamo a stringere il succo è quello: piacere, essere amati. Ammirati, approvati, applauditi, fai un po' tu.
Ci siamo capiti.
David Foster Wallace, "Oblio", “Caro vecchio neon”
«Nel mondo reale tutti soffriamo da soli; la vera empatia è impossibile.
Ma se un'opera letteraria ci permette, grazie all'immaginazione, di identificarci con il dolore dei personaggi, allora forse ci verrà più facile pensare che altri possano identificarsi con il nostro.
Questo è un pensiero che nutre, che redime: ci fa sentire meno soli dentro».
David Foster Wallace , “Un antidoto contro la solitudine. Interviste e conversazioni”
Quasi nessuna delle cose importanti ti accade perché l’hai progettata così.
Il destino non ti avverte; il destino sbuca sempre da un vicolo e, avvolto nell’impermeabile, ti chiama con un “psss” che di solito non riesci neppure a sentire perché stai correndo da o verso qualcosa di importante che hai cercato di pianificare.
David Foster Wallace
Il Postmoderno in una metafora.
Questi ultimi anni dell’
era postmoderna mi sono sembrati un po’
come quando sei alle superiori e i tuoi genitori partono e tu organizzi una festa. Chiami tutti i tuoi amici e metti su questo selvaggio, disgustoso, favoloso party, e per un po’ va benissimo, è sfrenato e liberatorio,
l’autorità parentale se n’è andata, è spodestata, il gatto è via e i topi gozzovigliano nel dionisiaco. Ma poi il tempo passa e il party si fa sempre più chiassoso, e le droghe finiscono, e nessuno ha soldi per comprarne altre, e le cose cominciano a rompersi e rovesciarsi, e ci sono bruciature di sigaretta sul sofà, e tu sei il padrone di casa, è anche casa tua, così, pian piano, cominci a desiderare che i tuoi genitori tornino e ristabiliscano un po’ d’ordine, cazzo… Non è una similitudine perfetta, ma è come mi sento, è come sento la mia generazione di scrittori e intellettuali o qualunque cosa siano, sento che sono le tre del mattino e il sofà è bruciacchiato e qualcuno ha vomitato nel portaombrelli e noi vorremmo che la baldoria finisse.
L’opera di parricidio compiuta dai fondatori del postmoderno è stata importante, ma
il parricidio genera orfani, e nessuna baldoria può compensare il fatto che gli scrittori della mia età sono stati orfani letterari negli anni della loro formazione.
Stiamo sperando che i genitori tornino, e chiaramente questa voglia ci mette a disagio, voglio dire:
c’è qualcosa che non va in noi?
Cosa siamo, delle mezze seghe?
Non sarà che abbiamo bisogno di autorità e paletti?
E poi
arriva il disagio più acuto, quando lentamente ci rendiamo conto che in realtà i genitori non torneranno più – e che noi dovremo essere i genitori.
David Foster Wallace, in L. McCaffery, An Interview with David Foster Wallace, “Review of Contemporary Fiction”, vol. XIII, n. 2, Summer 1993
http://www.storiadellafilosofia.net/davidfosterwallace/il-postmoderno-in-una-metafora/
Ci sono due giovani pesci che nuotano e a un certo punto incontrano un pesce anziano che va nella direzione opposta, fa un cenno di saluto e dice: - Salve, ragazzi. Com’è l’acqua? - I due pesci giovani nuotano un altro po’, poi uno guarda l’altro e fa: - Che cavolo è l’acqua?
Remo Bodei, David Forster Wallace
I pensieri e i timori di David Wallace
nei racconti inediti di Questa è l’acqua
di Massimo Vecchi
«
Ci sono due giovani pesci che nuotano e a un certo punto incontrano un pesce anziano che nuota
nella direzione opposta. Fa un cenno di saluto e dice; “Buongiorno ragazzi, com’è oggi l’acqua?”. I
due pesci giovani nuotano un altro po’, poi uno guarda l’altro e fa:
“Ma che cavolo è l’acqua?».
Con
questa storiella aveva inizio il discorso che David Foster Wallace,
il celebre scrittore americano
morto suicida un anno fa, rivolse ai giovani del Kenyon College, Ohio, nel giorno del conferimento
delle lauree, il 21 maggio 2005.
Intendeva che
siamo tutti come quei due giovani pesci, nasciamo,
viviamo, moriamo immersi in una realtà di cui non sappiamo.
Sono così i mille personaggi creati da
David Wallace nei suoi libri,
tanto esasperatamente egocentrici da non rendersi conto del mondo
che li circonda.
Poco più avanti lo scrittore inseriva nel discorso un’altra «storiella didascalica».
Eccola:
«Ci sono
due tizi seduti a un bar nel cuore selvaggio dell’Alaska.
Uno è credente, l’altro è ateo, e stanno
discutendo l’esistenza di Dio con quella foga tutta speciale che viene fuori dopo la quarta birra.
L’ateo dice:
“Guarda che ho le mie buone ragioni per non credere in Dio.
Ne so qualcosa anch’io di
Dio e della preghiera.
Appena un mese fa mi sono lasciato sorprendere da una spaventosa tormenta
di neve lontano dall’accampamento, non vedevo niente, non sapevo più dov’ero, c’erano
quarantacinque gradi sotto zero e così ho fatto un tentativo: mi sono inginocchiato nella neve e ho
urlato:
Dio, sempre ammesso che Tu esista, mi sono perso nella tormenta e morirò se non mi
aiuti!”.
A quel punto il credente guarda l’ateo confuso:
“Allora non hai più scuse per non credere –
dice – sei qui vivo e vegeto”.
L’ateo sbuffa come se il credente fosse uno scemo integrale:
“Non è
successo un bel niente, a parte il fatto che due eschimesi di passaggio mi hanno indicato la strada
per l’accampamento”».
DFW commentava:
«La stessa identica esperienza può significare due cose
completamente diverse per due persone diverse che abbiano due diverse impostazioni ideologiche e
due diversi modi di attribuire un significato all’esperienza».
Le conclusioni della “lectio magistralis” ai laureandi era la seguente:
«Qui la morale, la religione. il
dogma o le grandi domande stravaganti sulla vita dopo la morte non c’entrano. La Verità con la V
maiuscola riguarda la vita prima della morte.
Riguarda il fatto di toccare i trenta, magari i
cinquanta, senza il desiderio di spararsi un colpo in testa. Riguarda il valore vero della vostra
cultura, dove voti e titoli di studio non c’entrano, c’entra solo la consapevolezza pura e semplice: la
consapevolezza di ciò che è così reale e essenziale, così nascosto in bella vista sotto gli occhi di tutti
da costringerci a ricordare di continuo a noi stessi:
Questa è l’acqua, questa è l’acqua; dietro questi
eschimesi c’è molto di più di quel che sembra”».
LA PAROLA NON BASTA
Queste citazioni servono per tentare di illustrare il modo d’essere e il modo di scrivere di David Wallace.
Tentativo arduo, considerata la complessità del suo sentire, la sua eterna insoddisfazione [...]
La sorella Amy descrive gli ultimi giorni del fratello e dà la propria opinione sul suo gesto finale:
«
Il fatto di essere amato così tenacemente dai suoi amici, dalla sua famiglia, da sua moglie, non riusciva a penetrare la paura e la solitudine. Semplicemente, David ha esaurito la forza di sperare che domani forse sarebbe andata un po’ meglio».
E ancora: «Sebbene fosse spaventatissimo, non dormisse e perdesse tantissimo peso,
credo
che a consumarlo, alla fine, sia stata la paura di non essere mai più abbastanza in salute per
scrivere». [...]
Riguardando le opere di David Wallace dopo che si è tolto la vita si possono individuare non pochi
riferimenti alla morte, al momento del trapasso e anche al suicidio.
Nella raccolta di racconti
Oblio,
ce n’è uno dal titolo
Caro vecchio neon, scritto in prima persona,
il cui protagonista è un giovane
che si definisce un impostore perché fin da piccolo fa soltanto quello che può fargli fare bella
figura.
È un’altra citazione che si giustifica perché vi si trovano alcuni dei temi fondamentali della
narrativa e dell’esistenza di DFW: l’accusa alla parola di inadeguatezza, le ipotesi su quello che
avviene nell’istante in cui si passa dalla vita alla morte, il suicidio.
Dopo molti anni da impostore attraverso numerose vicende di vario genere e quasi altrettanti anni
trascorsi in analisi per cercare di cambiare, il protagonista decide che l’unica via d’uscita che gli
resta è togliersi di mezzo. [...]
È L’ORA DI FARLA FINITA
A un certo punto del racconto, la svolta:
«Dopo colazione chiamai l’ufficio per darmi malato e
rimasi a casa da solo tutto il giorno.
Sapevo che se avessi incontrato qualcuno sarei caduto
automaticamente nell’impostura.
Avevo deciso di prendere un flacone intero di Benadryl e poi
quando mi fossi sentito davvero rilassato e sonnolento sarei andato a tutto gas con la macchina su
una strada di campagna all’estrema periferia occidentale puntando dritto contro la spalla di cemento
di un ponte.
Il Benadryl mi rende estremamente confuso e sonnolento, lo ha sempre fatto.
Ho
passato quasi tutta la mattinata a scrivere lettere all’avvocato e al ragioniere collegiato, e brevi
notarelle al capo creativo e socio amministrativo che a suo tempo mi aveva fatto entrare nella
Samieti e Cheyne. Il nostro gruppo creativo era nel mezzo dei preparativi per una campagna
alquanto rognosa e volevo comunque scusarmi per il fatto di piantarli in asso».
E più avanti: «Prima
di prendere il primo Benadryl passai quasi due ore a scrivere a mano un biglietto per mia sorella
Fern. Nel biglietto mi scusavo per l’eventuale dolore che il mio suicidio e la mia disonestà e/o
incapacità di amare che lo avevano affrettato avrebbero potuto causare a lei e al mio patrigno». Qui
ricorda episodi del passato, incomprensioni, cattiverie concludendo che così facendo «si scopre che
un biglietto di suicidio ti dà modo di discutere cose che in altri frangenti sembrerebbero troppo
stonate».
Poi un elenco delle cose che tutti quelli sul punto di affrontare la morte finiscono per pensare:
«“Questa è l’ultima volta che mi allaccio le scarpe”,
“Questa è l’ultima volta che guardo il ficus
sopra lo stereo”,
“Come sembra deliziosa questa boccata d’aria”,
“Questo è l’ultimo bicchiere di
latte che berrò”»
e ancora «“Non sentirò mai più il rumore lamentoso del frigorifero in cucina”,
“Domattina non vedrò sorgere il sole né osserverò la stanza che esce dal vago e si viene
precisando”».
Qualche pagina dopo il narratore dialoga con il protagonista:
«Bene, e siamo arrivati
a quanto ti avevo promesso facendoti un riassunto noiosissimo di quello che c’è voluto per arrivarci
senza perdere la fiducia.
Cioè com’è morire, che cosa succede. Giusto?
È quello che vogliono
sapere tutti.
Anche tu, dammi retta...
Dal quadro d’insieme, come si suol dire, risulta che tutto
questo apparentemente interminabile andirivieni fra noi due ha fatto avanti e indietro nello stesso
istante in cui Fern mescola una pentola che bolle sul fuoco per il pranzo... e David Wallace sbatte le
palpebre mentre sfoglia oziosamente le foto dei corsi sull’annuario scolastico della scuola superiore
Aurora West» e trova nel 1981 la piccola foto di quel tizio «che era un anno avanti a lui, sempre
circondato da un’aureola, che sembrava quasi al neon, di superiorità scolastica e atletica e di
popolarità e successo con le donne, e (ricordi) legati anche a ogni osservazione tagliente o anche
minimo gesto o espressione disgustata da parte di quel tipo ogni volta che David Wallace si faceva
eliminare al terzo strike nelle partite di baseball dell’American Legion o aveva un’uscita infelice a
una festa».
Nelle ultime righe «essendo ormai passato parecchio tempo dal 1981, naturalmente, e David
Wallace è uscito da anni di conflitti letteralmente indescrivibili con se stesso con una potenza di
fuoco alquanto superiore rispetto ai tempi della scuola ad Aurora West» lo scrittore narratore si
chiede come «la parte più reale, più tollerante e sentimentale di lui» possa riuscire «a imporre
all’altra parte di tacere come se la guardasse negli occhi dicendo, quasi a voce alta: “Non una parola
di più”».
http://www.retididedalus.it/Archivi/2009/ottobre/LIBROSFERA/mix.pdf